Stamattina mi son svegliata con il pezzo di Luisa su Bob Dylan fresco di pubblicazione. Ero sinceramente interessata a sapere il suo parere, perché ogni volta che infila la poesia nei suoi discorsi imparo qualcosa di nuovo. Man mano che procedevo nella lettura, però, mi è sembrato sempre più chiaro che un interrogativo irrisolto rimanesse ad aleggiare tra le righe. Non per mancanza di Luisa, ma per una mia particolare attenzione a un aspetto della questione. Partiamo dall’inizio, però.
Da un lato, c’è la Grande Domanda su cui tutti si sono buttati a capofitto finora, ovvero: la canzone pop è letteratura? È, più nello specifico, poesia, nel suo andare a capo ed essere tendenzialmente legata alle logiche del ritmo? È ora di considerarla tale? Che ruolo hanno i cantautori nel nostro panorama letterario?
Chiariamo subito il fatto che non ho, nel modo più assoluto, un’opinione al riguardo. L’unica cosa che mi ha lasciata sinceramente dispiaciuta è che ci perderemo il fermento che l’assegnazione di premi come questo causa nelle librerie, condizionando la fortuna di un autore per tutti i mesi a venire. Come è accaduto quando Mo Yan vinse il Nobel nel 2012 e fino all’anno dopo alla libreria Coop di via Orefici praticamente ti lanciavano Sorgo Rosso addosso ogni volta che provavi a entrarci. E la cosa si ripercuoteva ovunque, inseguendo ogni sfortunato lettore come un’ossessione: facevi un giro alla Feltrinelli ed era lì, con le sue quasi cinquecento pagine e la sua fascetta, poi svoltavi in via Oberdan per la settimanale perquisizione al Libraccio ed eccolo di nuovo ma stavolta con il bollino «40% di sconto nuovo mai sfogliato». Ora sono impossibili da ritrovare – dubito perché l’edizione sia esaurita.
Tornando al pezzo di Luisa: il motivo che ha messo in moto la mia riflessione è stata la continua sottolineatura della nostra provincialità in quanto italiani nel concepire la cultura. Mi è spiaciuto molto che ci tocchi dover ancora riconoscere un fatto del genere e, ancora di più, doverlo usare come argomentazione. Soprattutto perché quanto sto per dire potrebbe invalidare ogni successiva argomentazione sul Nobel per la Letteratura da qui all’eternità mi rendo conto dell’importanza della cosa io vi ho preparati fate un respiro profondissimo:
noi italiani leggiamo in traduzione.
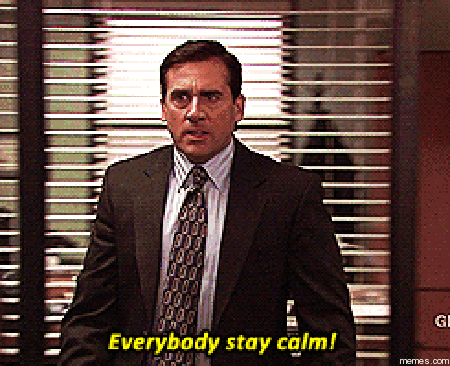
Potremmo aver già concluso qui, ma vediamo perché è un problema (sì, lo è) soprattutto relativamente al discorso della nostra percezione provinciale dell’assegnazione del Nobel a Dylan (dovevamo parlare di quello, giusto?).
Ora, l’attenzione e il rilievo che do alla questione, rispetto a quanto abbia fatto Luisa, penso dipenda semplicemente dal fatto che, per me, come lettrice e italianista, il problema della barriera linguistica è essenziale. Ne parla bene Elia Alovisi qui, quando ci spiega perché noi italiani facciamo così fatica ad apprezzare il rap, soprattutto quello non nostrano. Quando siamo stati al PrimaveraSound, i gruppetti di biondine caucasiche che zompavano altissimo su Pusha T urlando «Young nigga move that dope» facendo anche così costituivano praticamente metà del pubblico, lasciandomi contemporaneamente esaltatissima e dubbiosa, e rimane uno degli esempi sociologici più evidenti a cui abbia assistito negli ultimi anni. Cosa ne sanno (semicit.) queste regazzine del fatto che gli spacciatori lasciano ormai sempre di più la gestione e la vendita delle dosi a ragazzetti loro pari (delle biondine, dico, o anche più giovani), perché si muovono per i quartieri dando meno nell’occhio? Probabilmente nemmeno si sono accorte che è un testo politico e sociale, nel suo essere diretto e incisivo, senza i fronzoli patinati di quella (che un pochino mi stringe il cuore a chiamare la) versione italiana (nel suo intento di denuncia del disagio di una generazione senza futuro o quasi). Perché, smettiamola di girarci attorno, le parole sono cultura – e la cultura è molto più del linguaggio, ma è inevitabilmente veicolata da quello.
Giustamente Luisa si chiede perché non ci sia piaciuto il Nobel a Modiano di qualche anno fa e perché per noi la letteratura sia morta con Calvino. Beh, ma è facile: perché Calvino lo capiamo. Pascoli? Limpidissimo. Con un apparato di note fatto decentemente, persino l’ultimo dei millenials ti potrebbe fare l’analisi di Dante e racimolare uno stiracchiato sei.
Mo Yan, Modiano e Tranströmer, per citare sempre Luisa, no. Ci devono essere mediati, soprattutto linguisticamente. Riprendo dall’articolo di Elia:
Se mi trovo di fronte il testo di una canzone — rap, in questo caso — e non provo a comprenderlo criticamente, se me lo lascio scorrere addosso diciamo, non sto intraprendendo un processo di arricchimento personale. Questa acriticità semantica con cui approcciamo i prodotti culturali esteri ci porta probabilmente ad un maggiore coinvolgimento sonoro tout court: ci facciamo prendere dal beat, cantiamo il ritornello un po’ a caso, sbiascicando sillabe. Ci divertiamo: Dess no mi, actinlaiaueismen dess no mi.
E questo, Elia sottolinea, prescinde dall’idea di letteratura alta o bassa, aspetto su cui Luisa invece insiste molto, martellando sul problema dello snobismo che sembra appartenerci per eredità genetica. No, la questione va molto prima.
Il problema è un problema di lingua: non capiamo quello che stiamo ascoltando o leggendo. Mia madre, che ama Bob Dylan e che sta cominciando adesso a imparare un po’ di inglese per poter rispondere ai commenti su Instagram, mi chiede da anni di stamparle i testi e tradurglieli, perché dice che le piace la musica, capisce se la canzone è triste o felice, ma vorrebbe «tanto sapere cosa dice». Non è un po’ quello che ci chiediamo tutti, quando ascoltiamo un pezzo o leggiamo qualcosa che non è nella nostra lingua? «Che cosa ci sta dicendo?» Perché una delle due* funzioni−base della parola (e quindi del linguaggio) è la comunicazione.
E soprattutto: non ascoltiamo (quasi mai) le canzoni tradotte. I libri invece sì, li leggiamo (quasi) sempre tradotti. Probabilmente gran parte della nostra diffidenza nei confronti di questo premio ci viene dal fatto che a noi sembra molto più poetico un De André o un Tenco rispetto a un Dylan, perché (brutalmente) capiamo quello che stanno dicendo. Esattamente come per l’esempio che fa Luisa della Fontana di Duchamp o quello che fa Elia delle statue di Rodin, è questione di linguaggio, nel senso meno letterario e più linguistico possibile.
Torniamo un attimo al fatto che tutti vogliono dire la loro sulla storia del Nobel a Dylan. Io non ho seguito molto (per niente) la cosa, ma mi fido di Luisa che nomina più di un paio di volte Alessandro Baricco. Bene, prendiamo lui e facciamo un esperimento: cercate un attimo su Google “Baricco parla inglese”. Vi uscirà, tra i primi risultati, un assai probabilmente deprecabile canale YouTube (lo dico così, a intuito, dato che si chiama “Fascetta nera”) che ha caricato dei video di pochi secondi in cui Baricco in un contesto ufficiale chiede aiuto al pubblico perché confonde frog con fog, chiede «making a… scommessa?» e gli viene suggerito «bet» e lui tutto soddisfatto dice «making a Beth». E dov’è che abbiamo la nostra storia, Ale, che non ho capito bene?
Ora, il discorso di Elia si regge sul principio che ascoltare una canzone rap in lingua ci risulta effettivamente davvero difficile − lo è per chi quella lingua la parla, figuratevi per noi. E quindi ci perdiamo un sacco di cultura che in questo momento sta nascendo. E quindi, sì, alla fin fine è vero, come dice Luisa, che stiamo rimanendo marginali. Ma non perché non sappiamo far cultura dal nostro canto (see what I’m doing here?), ma perché non sappiamo relazionarci linguisticamente con quella del resto del mondo.
__
_
_
* L’altra è la rappresentazione. E adesso vado a tradurre le canzoni di Dylan alla mia mamma, che glielo devo dopo tutto questo.




