Dallo spagnolo mirar, guardare, il mirador è il belvedere che offrono le terrazze barocche di certe regge iberiche: parorami sconfinati sull’orizzonte etereo in tempo di pace, rilievi strategici in tempo di guerra. Un passaggio semantico che descrive bene la parabola storica, individuale e collettiva, vissuta all’epoca della scrittrice Irène Némirowsky: iniziamo evocando le suggestioni cosmopolite delle immense pianure innevate russe-ukraine, passando per l’esotismo erotico della Costa Azzurra e della Bidassoa, al fasto parigino, fino all’oscuro capitolo delle deportazioni naziste. Nel mezzo la vita che pulsa: la letteratura e la famiglia che Irène ha condiviso con Michel Epstein.
Una donna magnetica Irène, romanziera dotata e di successo, definita la Françoise Sagan degli anni Trenta, una scrittrice ossessionata e ispirata dall’infanzia e dall’adolescenza -, essenzialmente un lungo periodo di sospensione* ‘subito’ all’interno di suntuosi milieux orientali, poi europei, in virtù della ricchezza del padre – il cui alter ego sarà trasposto nella solitudine dell’uomo d’affari, David Golder –, ambienti lussuosi, arredati da una madre mondana, frivola, seduttiva, sempre alla ricerca delle adulazioni di giovani amanti. Ben presto Fanny – nomignolo di questa madre tanto odiata – comprenderà l’ostilità della figlia, tuttavia in niente modificherà le sue abitudini. Probabilmente è proprio per questo che la collera e lo sdegno d’Irène sono diventati ancora più taglienti e hanno potuto sfogare il loro potenziale distruttivo nella sublimazione della creazione letteraria: le trame saranno sempre infestate da almeno una figura femminile ricorrente dalla silhouette elegante ma dall’animo voglare, viziato, capriccioso. È facile identificare quest’ombra al fantasma materno nell’eccentrica Ida, per esempio, o nella prodiga Jézabel. Uno spettro onnipresente e onnipotente, incarnato talvolta da personaggi secondari, simbolo di una transizione del femminile: la madre simbolo della potenza sessuale per una bambina, viene superata e resta come ricordo alle spalle della bambina diventata donna, proprio come in Suite Francese. Bisogna riconoscere che la tragedia si realizza in modo esemplare nell’intrigo de Il Ballo: estensione massima della consumazione di una vendetta perfetta, trasposizione dell’assassinio simbolico premeditato, deliberata rappresentazione psicologica di una pulsione aggressiva-passiva viscerale, emotivamente difensiva originata dalla deformazione del complesso di ‘essere cattive’. Confessare la paura di ‘peccare di perversione per forza maggiore’, non esserne colpevoli, ma diventarlo per poter riprendere il potere di esistere, un sentimento di detonazione contro l’impotenza. Ne Il vino della solitudine si legge: «Lei pensava con disperazione: – Divento cattiva, adesso, come gli altri…».
Allora, poiché Fanny era troppo «ferocemente femmina», il ruolo materno passa di diritto alle governanti – alle njanja. Ricordi affettivi immensamente cari ai quali Irène dedica un ritratto commovente ne Le mosche d’autunno: le governanti rappresentano la nostalgia di un mondo perduto – quello del calore della casa sicura -, soprattutto sono vestali della protezione amorevole, della cura, custodiscono ciò che è prezioso – così anche guardiane delle tradizioni e dei segreti, una sorta di memoria vivente delle generazioni di cui testimoniano l’identità.
Potremmo dire di un certo sentimentalismo čechoviano. Del resto è la vena russa d’Irène che ha conquistato tutto il pubblico sin dagli esordi, ma anche la critica, certo ricorrendo a un piccolo escamotage. Sarà il suo primo editore, Bernard Grasset a spiegarle: «il lancio di un libro necessita che si sollevi nel lettore un asse di curiosità. Nel suo caso, sarà doppio: innanzitutto lei è russa in più lei scrive in lingua francese. È un argomento pubblicitario possibile, ma non sufficiente. (…) Toglieremo solo dua anni alla sua età reale». Irène aveva all’epoca ventisei anni.
Irène Némirovsky ha studiato letteratura alla Sorbona ottenendo una laurea in Letteratura russa. Già in gioventù soffriva di una forte miopia (come la piccola Catherine Certitude), ma non ha avuto fretta di correggerla per approffittare delle sfumature romantiche e soggettive di una realtà dalla patina sfocata. Irène amava le novelle di Puškin; le stilografiche dall’inchiostro blu dei Mari del Sud e i gatti neri che ha sempre battezzato, uno dopo l’altro, inesorabilmente come il primo, Kissou. La sua professione di fede – ripetuta come un mantra in risposta a certi attacchi della critica – era implacabile: «sono una donna libera nessuno può dirmi cosa scrivere». Un temperamento fiero e orgoglioso tipico, forse, di coloro che hanno sofferto il trauma dell’abbandono e del rifiuto durante la più tenera età, diventando impazienti di riscattarsi e facendo di sé stessi, in attesa, un nocciolo duro. Lavorare con la vita. Sempre ne Il vino della solitudine (romanzo apertamente, e quasi interamente, autobiografico) si legge: «Di cosa mi lamento? .. Tutto il mondo è come me. Sicuramente, tutte le case sono popolate da donne adultere, di bambini infelici e di uomini occupati, che non pensano che ai soldi.. Con i soldi, tutto vi lusinga, tutto sorride, tutto si sistema, dicono. Ho dei soldi, sono in buona salute, ma mi annoio…». Maturando, Irène non mancherà di comprendere e di definire il cammino interiore : «the aim of my life is self-improvement».
Questa soffice traccia biografica è l’eredità delle sue figlie: Denise aveva dodici anni quando Irène fu deportata, Élisabeth – soprannominata Babet – era ancora troppo piccola per comprendere il senso della scomparsa di entrambi i genitori. Dopo l’arresto di Irène e Michel, per le due sorelle è arrivato il tempo di affrontare l’inferno e la solitudine. Denise, in occasione di una conversazione con Clémence Boulouque, a proprosito della salvezza, dell’essere sopravvissuti e del tempo della sopravvivenza ha affermato che «la vita è un regalo avvelenato». Del resto, la loro resistenza è stata nutrita dallo sforzo di trovare il coraggio di accettare un futuro di normalità e equilibrio – l’impossibile. Forse era questa la scommessa azzardata e dalle fondazioni precarie, ma anche la sola speranza in seno al dolore che distrugge: ossia l’attesa di una rigenerazione possibile, spegnere la guerra invisibilmente infinita. Servirà loro – comme scriverà Carol Shields in The Stone Diaries – «raccogliere coraggio per avere coraggio».
A osservarle dall’esterno, mi pare che la forza morale sia stata investita tessendo il tessuto della sofferenza con la stoffa del corpo (immaginato) della madre, matrice, radice, ricucendolo. Questo movimento d’orlatura e ricamo anima e punge la lettura di Le Mirador. Mémoires rêvées di Élisabeth Gille.
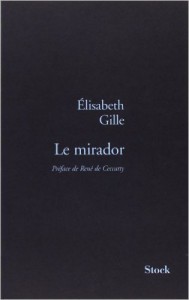 Babet, la figlia minore che ha adottato il cognome della famiglia che l’ha cresciuta, è diventata a sua volta scrittrice, oltre che traduttrice e direttrice letteraria per Denoël, casa editrice francese per la quale ha curato la prestigiosa collezione science-fiction-Présence du futur, passando poi alle edizioni Rivages, specializzate nella letteratura straniera e poliziesca, fino all’insorgere della malattia che sarà la protagonista de Le Crabe sur la banquette arrière (1994).
Babet, la figlia minore che ha adottato il cognome della famiglia che l’ha cresciuta, è diventata a sua volta scrittrice, oltre che traduttrice e direttrice letteraria per Denoël, casa editrice francese per la quale ha curato la prestigiosa collezione science-fiction-Présence du futur, passando poi alle edizioni Rivages, specializzate nella letteratura straniera e poliziesca, fino all’insorgere della malattia che sarà la protagonista de Le Crabe sur la banquette arrière (1994).
L’elaborazione di questo nuovo, ultimo esilio – la malattia – l’ha risvegliata all’urgenza di ordinare lo specchio frantumato del suo mancante, di quello che le è stato violentemente precluso, vuoti di senso, pieni d’angoscia intorno alla madre straniera, la sua sconosciuta. Denise – sempre in Sopravvivere e vivere – ha confermato che Le Mirador è una sorta di biografia redatta da Élisabeth che ha ‘finto’ di essere Irène-autobiografa. Tuttavia è un lavoro che entrambe hanno coltivato: questo complesso risvolto psichico le ha riunite. Due sorelle che collaborando alla ricostruzione del dedalo materno hanno messo da parte i silenzi e le incomprensioni e le interruzioni trovando nuove parole, significati comuni, la consolazione e l’empatia di fronte al perturbante della genealogia violata. La potente fibra della narrazione – votata a riportare in vita ciò che era sospeso, ossia colei che era rimasta in sospeso – ha reso, allora, dignità all’umanità personale.
Tutto è iniziato per caso: siccome alcuni studiosi avevano in progetto di realizzare una biografia su Irène, le due sorelle sono state contattate e a quel punto hanno compreso che la storia che sarebbe stata recuperata apparteneva a loro più che a chiunque altro. Hanno iniziato a seguire questa loro storia, in qualità di figlie, vive, di una madre persa in un tempo lontano, in un tempo sommerso in cui anche la loro vita si è fermata colata a picco nell’incoerenza della fune spezzata.
Le Mirador nasce pragmaticamente dall’esplorazione degli archivi della Biblioteca Nazionale di Francia, ogni tassello per conoscere Irène e le date che la riguardano, ma soprattutto sarà preziosa la rilettura degli indizi contenuti nei libri di cui è autrice e che secondo Babet (già editor) sono superiori a quelli di Colette e Berberova, nessuna aveva quell’occhio di pittrice in guisa di penna.
Tecnicamente l’operazione letteraria capitale di Le Mirador è la scelta di reinterpretare il genere biografico contaminandolo con la fictio autobiografica. Si tratta di un romanzo, infatti, scritto in prima persona singolare, per creare giustamente l’illusione di ‘essere’ o di ‘stare leggendo’ Irène e nessun’altra. C’è la sperimentazione della giustapposizione e della fusione dell’io-narrante e del sé-narrato, due poli che nonostante tutto non coincidono e non coincideranno. In un certo senso, possiamo parlare di ribaltamento, similmente a quello applicato da Gertrude Stein per la sua Autobiografia d’Alice B. Toklas (nel cui caso, però, l’esplicitazione dello sfasamento compare nel titolo). Nei due modelli, si ritrova la torsione del reale che passa per la scrittura, che sostituisce l’«AltrA necessaria» (definizione della filosofa italiana Adriana Cavarero in Tu che mi guardi tu che mi racconti – Relating narratives).
L’esposizione all’altrA nella vulnerabilità dell’«io» fonda l’autofiction, scrive Cavarero: «Cosa importa che voi siate simili o consonanti, la vostra storia non sarà mai la mia». La filosofa americana Judith Butler ha spiegato in maniera ancor più generale: «Cavarero difende l’idea di una irriducibilità di ciascuno dei nostri esseri che diventa chiara attraverso le differenti storie che possiamo raccontare, di modo che ogni sforzo di identificarci a un ‘noi fusionale’ fallirà necessariamente». A tutto questo realistico buon senso, Gille sembra rispondere: “importa perché mentre me la raccontavo, stavo un po’ di tempo lì con lei che è l’altra che c’è sempre anche se non c’è stata più”. Sarebbe questo un paradigma della ferita narcisistica – specificamente identitaria – che si cerca di riparare/guarire senza fine?**
Storia identitaria che esiste nella misura delle risonanze ch’essa suscita nell’altra. Si tratta di una «scena d’interpellazione». Sul punto, Isabelle Grell et Arnaud Genon – nel blogautofiction.org – hanno cercato di definire in questi termini l’autofiction:
L’autofiction si è imposta come uno de cantieri più aperti, più vitali della letteratura attuale. Nozione sottile da definire, legata al rifiuto che un autore manifista al riguardo dell’autobiografia, del romanzo a chiave, delle imposizioni o dei richiami alla trasparenza, si arricchisce delle sue multiple estensioni resistendo al contempo, solidamente, agli attacchi incessanti di cui fa l’oggetto. Arriva, effettivamente, a porre delle domande spinose alla letteratura, facendo così vacillare le nozioni stesse di realtà, di verità, di sincerità, di fiction, scavando gallerie inattese nel campo della memoria.
Più della filosofia può dunque l’arte per integrare questo slancio. Ci soccorre l’installazione della scultrice plastica contemporanea, appartenente alla corrente stilistica dell’autofiction, Sophie Calle: Dolore eccelso – Douleur exquise (esposta al Centre Pompidou nel 2004), con riferimento ancora una volta al rapporto materno, o meglio ‘con la propria madre’ questo dolore si estrinseca in Mère à perte de vie. Madre a perdita di vita (che richiama le allucinazioni primigenie che possono prodursi nel mezzo del mare a perdita di vista o che invadono i sogni ‘allagati’ da distese d’acqua più o meno calma) è un tentativo di non evadere ‘il bisogno di madre’ e di metterlo ‘di peso’ sulla scena. In un’intervista tutto assume un’ulteriore grave franchezza. È viscerale, è senza pudore l’anello di congiunzione a sé e non teme alcuna provocazione perché è un’evidenza terrena.
Tuffarsi nella morte della propria madre, proiettare i suoi ultimi istanti di vita, non è un po’ macabro?
Di fatto, dalla morte di mia madre, dal montaggio del progetto, lei è là, più viva che mai. Adorava stare al centro dell’attenzione. Ancora un po’ che se la trovassi, rincasando, non ne sarei sorpresa.
Nel caso delle sorelle Gille-Epstein, l’AltrA è assente del tutto perché d’Irène non c’è stata più traccia, ‘sottratta’, nemmeno la morte è in loro possesso per il processo luttuoso, così Le Mirador ha anche l’effetto di ripetere lentamente la perdita, la sottrazione, controllandola, il corpo del testo è lo scritto che copre il grido e rende il rischio di follia mansueto. Ma non è solo per queste ragioni che ‘fingere l’autobiografia’ come genere è stato importante: è proprio a proposito del genere autobiografico che Derrida ha affermato:
«l’autobiografia non è tale in ragione del fatto che chi la firma racconta la propria vita; ma in quanto si racconta tale vita, cioè in quanto è il primo, o semplicemente il solo, destinatario del racconto»
Mi sembra questa chiave d’analisi più aderente nel processo di elaborazione dell’opera: Élisabeth svolgendo un’ultima volta i capitoli della storia della madre ha preso il tempo fisico di immaginarsela, di vedersela scorrere davanti, in consonanza poi (scrittura-rilettura), per arrivare a porter accettare di porre la ‘conclusione’. Madre e morte coincidono in maniera inversa a quel che sappiamo di noi: che la madre è da dove abbiamo preso inizio. Così a spirale, non solo tutte le fasi le hanno permesso di rivedersi nascere, quindi esistere, ed essere negli intrecci relazionali della madre per potersi finalmente separare, ma conseguentemente e ulteriormente tali tappe le hanno restituito la chance di rinascere alla sua propria differenza, d’emblée riemersa, visibile, tangibile, germoglio.
Questa proiezione acquista un valore di sutura psichica che sfratta l’orrore e l’ingiustizia e che libera la postmodernità della nostalgia quale stato d’animo immemore tormentato dall’impietosità del male assoluto ‘disincarnato’ in spirito di morte durante le persecuzioni. In merito all’emersione della soggettività-rammemorante in relazione alla Seconda Grande guerra, la filosofa italiana Rosella Prezzo ha scritto: «l’operazione di attraversare in viaggio i paesi dell’infanzia è uno dei mezzi per la ricerca del sé-bambina che è stato vissuto sotto il segno del nazismo, e che, tuttavia, è ormai diventuto una inaccessibile ‘terza persona’ del pronome ‘io’. Nel cuore del dialogo della memoria, questo ‘io’ si decentra declinandosi come ‘tu’».
Siamo di fronte a un’opera che è una dichiarazione di amore – un amore maturato affrontando le contraddizioni e i suoi opposti e prima di tutto imporre un criterio d’ordine alla confusione, una (ri)costruzione personale che raggiunge il mondo rimanendo, nella sua vocazione, una consegna di bene che testimonia il lungo sentiero della purificazione e dell’elevazione. Il mattone che illumina e scalda. O un mirador , dal francese stavolta: un nascondiglio in alto, dove sognare verso il cielo tra le braccia di un albero. Un nido.
————-
*Una declinazione di questo sentimento lo abbiamo trattato in relatione alla poetica di un’altra grande scrittrice, Silvina Ocampo.
**Un interessante riferimento a questa implicazione elaborata in campo psicoanalitico lo troviamo nell’intervento di Julia Kristeva raccolta nel testo Le Symptôme et le Savoir di Maud Mannoni, ed. du Seuil, Paris, 1983, pp. 111-112.




