Qualche tempo fa mi sono resa conto di essere vittima di un grosso bias. Nonostante io faccia parte della comunità LGBT+ e mi ritenga generalmente una persona aperta e rispettosa del prossimo, durante una conversazione mi sono resa conto che avevo dei pregiudizi sull’asessualità. Non sapevo niente di questa realtà, e le prime cose che mi venivano in mente erano stereotipi infarciti di presupposti medici senza alcun fondamento (sono malati? hanno squilibri ormonali? sono depressi? sicuri che stanno bene?).
Compreso che c’era un problema, ho provato a cercare una soluzione. Non conoscevo persone asessualə con cui parlarne, dunque ho deciso di informarmi per altre vie: ho cercato un gruppo Facebook dedicato al tema, ho mentito spudoratamente alle domande di accesso, e una volta dentro me ne sono stata zitta in un angolo ad ascoltare, finché lo stereotipo dell’asessuale medio nella mia testa non è diventato così vario e complesso da non essere più tale, e si è scollato naturalmente da pregiudizi di tipo clinico.
Forte di questa esperienza, ho cominciato a curiosare tra i gruppi Facebook, credendo che in qualche modo frequentare realtà a me sconosciute avrebbe in qualche modo ampliato la mia visione ristretta del mondo (quella di chiunque lo è). La mia attività di spiona silente si è intensificata, e qui mi sono resa conto di due paradossi:
1) se vuoi entrare in un gruppo chiuso, anche se hai le intenzioni migliori del mondo, sei costretto a mentire. Nei gruppi sono benvenute solo le persone che vi si identificano. Quelle che non vi si identificano ma sono semplicemente curiose sono guardate con sospetto. E con buonissimi motivi: l’agguato del troll, del bullo, del tipo delle risorse umane che indaga, dell’idiota che vuole rovistare nel tuo safe space, è dietro l’angolo. Sempre e comunque.
2) se sei in più gruppi chiusi che manifestano un’etichetta forte e chiara (sono asessuale! sono enby! sono monogamo! sono un goblin!) e allo stesso tempo sei in un gruppo che manifesta un’identità idealmente opposta in quello spettro (sono pansessuale! sono cisgender! sono poliamorosə! sono una fata!) le persone ti guardano con sospetto triplicato. Essere più cose insieme contemporaneamente non è ben visto, in genere, nemmeno tra le minoranze (figuratevi se in tutto questo pandemonio di gruppi te ne vieni fuori dicendo che sei bisessuale).
Dunque mi sono resa conto che pur allargando gli spazi, i bias invece di ridursi si moltiplicano, le dinamiche di prevaricazione che le minoranze esperiscono nella maggioranza si riproducono in piccolo e in grande in ogni gruppo che nasce da un’etichetta definita.
E questo all’infinito. Vedevo il problema, ma non mi era chiaro dove nascesse.
Poi ho letto In altre parole di Fabrizio Acanfora (effequ, 2021), e qui ho trovato la connessione con il linguaggio. Perché continuiamo a dividerci in gruppi, a sentirci sbagliati quando non ci identifichiamo nella maggioranza, o in più etichette che sembrano slegate tra loro? Acanfora individua gran parte di questo problema nelle parole, e proprio sulle parole indaga direttamente.
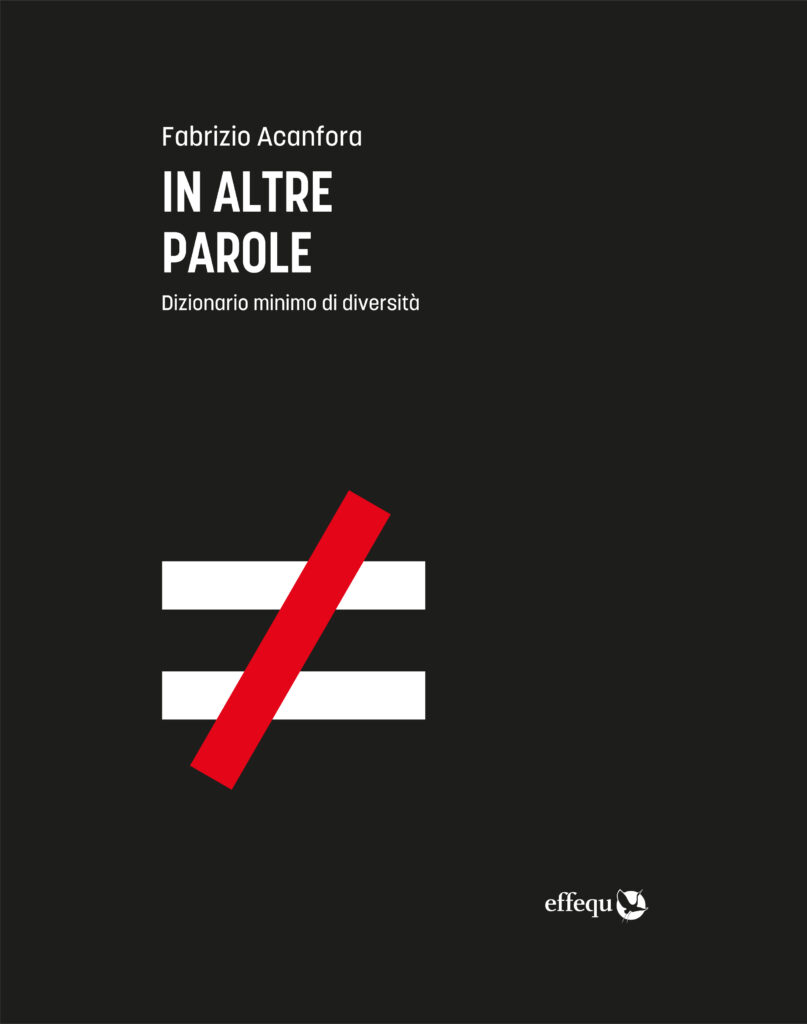
Avevo molte aspettative su questo libro, perché il precedente volume dell’autore, Eccentrico (effequ, 2018), fa qualcosa di davvero difficile da reperire in Italia: scrivendo dal punto di vista di una minoranza (l’autismo), offre sollievo a chi di questa minoranza ne fa parte, facendolə sentire banalmente legittimato a esistere, e fornisce strumenti di convivenza e comunicazione alle persone neurotipiche (cioè non autisticə). Eccentrico era già una sorta di dizionario, insomma, che a mio parere può diventare utilissimo quando tra una persona autistica e una persona neurotipica si creano delle incomprensioni – cosa che purtroppo è piuttosto frequente.

Se allarghiamo la prospettiva di queste “incomprensioni” a un bacino più grande, notiamo che tanto spesso incomprensioni non sono, ma si tratta di precise scelte della lingua per denotare un deficit nel prossimo e privarlo del potere di scelta e autodeterminazione. Ci accorgiamo allora che il problema non riguarda solo autisticə e disabilə in generale, orientamenti sessuali e identificazioni di genere, ma ogni definizione che riduce la persona a un’etichetta: «Pigro, svogliata, inetto, pervertito, pazzo, malata, imbecille, autistica, mongoloide, schizofrenico, depressa, ritardata, mezzo uomo, frocio, omosessuale, maschio, femmina, alta, basso, nero, straniero, italiana, araba, dislessico, inopportuno, normale, diversə, difettoso, perfetta, cristiano, musulmana»[1].
Le mie aspettative dunque non sono state deluse, perché questo “dizionario minimo di diversità” allarga l’intento di comunicazione e comunicabilità a un quadro più grande, fa da ombrello idealmente a ogni minoranza, tendendo contemporaneamente una mano da un lato e una dell’altro, per mediare una comprensione.
Una comprensione ben diversa dal concetto di inclusione, che «non si traduce in una reale uguaglianza delle parti»[2], per introdurre invece quello di convivenza, dove «noi esseri umani siamo in partenza tuttə dentro»[3].
In altre parole sceglie con attenzione una serie di termini che riguardano ciò che la maggioranza considera i cosiddetti “loro”, gli “altri”. Con questi costruisce un kit comunicativo che ha l’obiettivo di superare i bias e portare a una risignificazione di parole che evocano gli stereotipi, che dividono le persone in gruppi, che minimizzano identità a poche caratteristiche, rendendo patologico tutto ciò che non è frequente (la disabilità, la diversità di genere, gli orientamenti sessuali non eteronormativi, ogni diversità fisica, neurologica, sensoriale e comportamentale).
La proposta dell’autore, non è quella di calare questi significati dall’alto, rischiando di scatenare la classica ritorsione dei bulli sui paria dopo una sgridata dell’insegnante. Ma agire dal basso sulla lingua, quotidianamente, per modificare i significati di parole che portano con sé pregiudizi e che quando usate attuano prevaricazioni reali nella vita delle persone.
Essendo io poi una spiona curiosa non mi sono fatta bastare il libro, e ho fatto qualche domanda in più a Fabrizio, che è stato tanto gentile da rispondermi.
Cosa ti ha spinto a lavorare a questo libro?
Dall’uscita di Eccentrico, il saggio autobiografico sull’autismo pubblicato nel 2018 sempre con effequ, ho cominciato a parlare di autismo, neurodivergenza e neurodiversità, e mi sono accorto che la maggior parte degli argomenti e delle problematiche trattate non potevano essere limitati alla sola categoria delle persone autistiche. Ne è nata una riflessione sul carattere intersezionale della diversità, e da lì è scaturita l’esigenza di affrontare l’argomento in modo più ampio.
Hai usato un metodo, nella selezione delle parole che avrebbero fatto parte del dizionario? Ce ne sono alcune che hai escluso, e se sì per quale ragione?
Inizialmente ho scelto quelle parole che durante i vari incontri, webinar e conferenze sulla neurodiversità e la neurodivergenza, ho notato avere maggiore peso nel discorso sulla diversità. In particolare ho focalizzato l’attenzione sia su quei termini per me fondamentali ma che ancora non fanno parte né dei dizionari né del nostro vocabolario quotidiano, come la parola abilismo, sia su quelle parole che utilizziamo senza soffermarci sul loro significato e sull’impatto che hanno nelle nostre vite e in quelle delle persone a cui si riferiscono, come la parola diversità, ma soprattutto normalità.
Nel libro parli in modo dettagliato della nascita del concetto di “normalità”, di come si è instaurata l’idea di “uomo medio” e della conseguente patologizzazione delle diversità.
Fai un quadro molto chiaro degli elementi che compongono la base cognitiva che porta “la maggioranza” a provare imbarazzo, o addirittura fastidio e disgusto davanti a chi manifesta “stranezze” (quindi soprattutto verso i disabili fisici, poiché la diversità è subito evidente).
Davanti alla fluidità, poi, molte persone perdono totalmente la testa. Cos’è che spaventa tanto della fluidità, delle identità non facilmente etichettabili? C’è una storia da cui possiamo imparare, che si interseca con quella della “normalità”? O è una paura tanto arcaica da essere la causa di questa deriva?
La non conformità ai comportamenti, agli ideali e in definitiva alla cultura della maggioranza ha da sempre generato sospetto e a volte timore, anche quando il concetto di normalità non era ancora stato definito e istituzionalizzato.
Come spiego nel libro, una parte dei meccanismi che ci spingono a sospettare di chi appare diverso e spesso a rifiutarlo, sono il risultato della stratificazione di comportamenti che si sono dimostrati vantaggiosi a livello evolutivo per la nostra specie, come la preferenza per i membri del proprio gruppo familiare, del proprio clan, in modo da ottimizzare le risorse e massimizzare la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio genetico alle generazioni future. Ma oggi le nostre condizioni di vita sono cambiate completamente, abbiamo creato e sviluppato religioni, culture, tecnologie sofisticatissime, abbiamo creato l’arte, eppure ancora rimangono in alcuni nostri comportamenti dei residui, come eco biologiche di quelle strategie arcaiche.
Da un punto di vista storico e culturale poi trovo interessante considerare che prima della definizione dell’ideale di persona media, prima della codificazione di alcune caratteristiche e della categorizzazione delle persone in base ad esse, la diversità era riferita a quei comportamenti o caratteristiche specifiche e non necessariamente all’individuo.
Pensiamo ad esempio all’orientamento sessuale. Prima del 1870 non esisteva la parola omosessuale, e nel passato a essere accettati, tollerati o condannati erano determinati comportamenti, non la persona in quanto omosessuale. Da un certo punto in poi l’individuo nella sua interezza è stato categorizzato come normale o anormale in base a quelle caratteristiche.
Il progresso scientifico in questo senso ha contribuito ad aumentare lo stigma sociale associato alla diversità. Molte caratteristiche della persona, come l’aspetto fisico, la sua neurologia, la psicologia, il comportamento, sono diventate di dominio della medicina, e quando non rientrano nei canoni della salute (ossia “normalità” dal punto di vista clinico) anormali, malate, si trasformano in difetti e deficit da riparare col fine di riportare la persona verso un funzionamento il più “normale” possibile.
Col passare del tempo però ci siamo in qualche modo abituati all’esistenza di certe caratteristiche. Non le comprendiamo o accettiamo tutte, in molti casi continuiamo a rifiutarle anche in modo violento, a condannarle, come l’orientamento sessuale non diretto verso il sesso opposto è condannato in alcuni paesi ancora oggi. Il fatto che tali caratteristiche appartengono a gruppi ben precisi le rende identificabili, se ne può stare alla larga, si possono riconoscere e gestire.
Ma i concetti di intersezionalità e fluidità vanno oltre e scardinano i confini di tali categorie. Questo spiazza, fa paura e, cosa apparentemente paradossale, a volte fa paura proprio a chi di quelle categorie (le minoranze) fa parte. Quanti attivisti per i diritti di una categoria specifica abbiamo sentito scagliarsi contro il concetto di fluidità di genere, di linguaggio inclusivo?
Al capitolo “Ispirazione” parli dell’ispiration porn, cioè della rappresentazione che «essenzialmente usa alcune caratteristiche della diversità come fonte di ispirazione per la normalità»[4]. Si parla quindi di quel tipo di esposizione della disabilità o di altre caratteristiche della persona come fossero “ostacoli” da superare con un certo impegno ed entusiasmo, per diventare così “funzionali”. In ottica intersezionale, l’ispiration porn mi ha ricordato le classiche pubblicità degli assorbenti, dove qualsiasi persona di qualsiasi età può fare capriole, sollevare pesi, ballare, marciare a lavoro in tacco dodici nonostante abbia le mestruazioni. Questa rappresentazione a doppio taglio da un lato ci dice che le mestruazioni sono un deficit, e dall’altro che l’individuo deve investire la propria volontà nel superare il deficit e tornare a essere performativo.
Nella società in cui viviamo è chiaro che la performatività equivale alla capacità di produrre e consumare. Possiamo dunque fare una sintesi e dire che oggi normalità=(ri)produttività?
Assolutamente sì. La nostra concezione odierna di normalità è estremamente legata alla produttività (e anche, ovviamente, alla riproduttività come forma di produttività). Essere percepite come persone non produttive è una colpa. Siamo sommersi da libri, video, teorie, guru che fondamentalmente ci dicono che dobbiamo migliorare, che il potere di cambiare il nostro destino è nelle nostre mani, che dobbiamo fare di tutto per diventare produttivi nonostante alcune nostre caratteristiche, come ad esempio un corpo o una neurologia differenti, ma anche l’essere donna, come facevi notare. In pratica, dicendoci che dobbiamo migliorare, rendendo alcune nostre caratteristiche difetti da superare, ci viene detto che come siamo non andiamo bene, e sostenendo che solo noi possiamo cambiare il nostro futuro, si solleva la società da ogni responsabilità nell’esclusione di alcune categorie dall’avere le stesse opportunità della cosiddetta maggioranza.
La diversità, soprattutto quando fisica e psichica, diventa inoltre fonte di ispirazione per la normalità; quelle differenze che normalmente sono stigmatizzate, come un corpo non conforme, una mente che funziona in modo diverso, vengono oggettivate e usate come paragone e come spinta per le persone “normali”. Il messaggio è in pratica: “se ce la fanno loro, che sono così sfortunati, disgraziati, che soffrono per essere come sono (e non perché noi li trattiamo come esseri inferiori…), che scusa hai tu per non provarci?”.
Il porno motivazionale, modalità a volte utilizzata con le migliori intenzioni, non fa che umiliare la persona che diviene oggetto di quel paragone, che diventa ispirazione per aver fatto qualcosa “nonostante” sia com’è.
Una delle proposte di In altre parole è quella di risignificare gli stereotipi, meccanismi di scelta rapida e non qualitativa, invece di perdere tempo a combatterli. Questa pratica dipende dalla lingua, da quelle parole che tendono a ridurre identità complesse a etichette. La tua proposta è quella di concentrarci sull’uso quotidiano di queste parole, spendendo più tempo nella scelta di come e quando usarle. Quali sono, secondo te, gli strumenti più efficaci per dare nuovi significati a uno stereotipo? Tra i vari strumenti possibili, l’ironia è efficace o dannosa?
L’ironia può essere un mezzo molto efficace in questo senso purché però venga percepita come tale e interpretata correttamente, perché se venisse fraintesa potrebbe portare a situazioni peggiori di quelle che si vorrebbe modificare.
In generale credo che lo strumento principale sia la consapevolezza della responsabilità di ciascuna persona nell’uso del proprio linguaggio, delle parole che sceglie, dell’aderenza di determinate generalizzazioni alla realtà.
E qui vorrei precisare una cosa. Questo non vuol dire che non si possa più fare battute, che “non si possa più dire nulla”, o che sia in atto una sorta di dittatura delle minoranze, del cosiddetto “politicamente corretto”. In realtà chi sostiene simili assurdità vorrebbe semplicemente un lasciapassare per poter offendere, per poter insultare o ridicolizzare quelle persone che finalmente, grazie anche alla visibilità concessa dalla tecnologia, semplicemente non rimangono più in silenzio a subire certi comportamenti discriminatori. Insultare, ridicolizzare per il colore della pelle o l’orientamento sessuale, non è mai stato giusto. Non è che quando mi si chiamava frocio da adolescente io non ne soffrissi, solo che adesso posso farlo notare, posso oppormi grazie alle reti sociali, posso scrivere un’email a un giornale. E questo non piace a molte persone.
Ma soprattutto, quali sono i comportamenti da evitare per generare l’effetto contrario? Come si evita di rafforzare uno stereotipo nel tentativo di cambiarlo?
Come dicevo, consapevolezza e responsabilità credo siano gli strumenti essenziali in una società che si basa in modo così massiccio sulla comunicazione. Chiunque può commettere errori, capita a me, a te, capita anche alla persona più attenta perché nessuno può avere una conoscenza approfondita di tutte le sfumature e le realtà di un mondo sempre più fluido e in costante cambiamento.
Spesso, come ad esempio nel caso del genere dei pronomi o del linguaggio che determinate categorie preferiscono sia utilizzato nei loro confronti (penso al linguaggio identity-first o person-first con le persone autistiche o disabili), a volte è sufficiente domandare.
Nel caso specifico degli stereotipi, queste generalizzazioni che utilizziamo costantemente per conoscere la realtà, un primo passo è essere consapevoli che molte descrizioni interiorizzate di determinate categorie sociali, potrebbero non corrispondere alla realtà ma essere il frutto dello sguardo della maggioranza. L’autorappresentanza delle minoranze, ossia il potere di esercitare il diritto a decidere della propria rappresentazione nel mondo, è uno strumento potentissimo in questo senso perché permette ai diretti interessati di fornire la narrazione che riguarda loro.
Ultima domanda, con cui provo ad allargare il quadro. Per mostrare come la diversità sia un concetto a sé stante, e non il contrario della normalità, porti la definizione di biodiversità: «variabilità tra gli organismi viventi di ogni origine compresi, tra l’altro, gli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici e i complessi ecologici di cui sono parte; questo comprende la diversità in una stessa specie, tra le specie e quella degli ecosistemi»[5].
Esiste una reale intersezionalità, se non vi si includono “gli altri” per eccellenza, cioè animali, piante e materiali? È possibile cambiare i rapporti di potere tra maggioranza e minoranze che sono radicati nel linguaggio, se già solo per l’esistenza di questo linguaggio abbiamo eletto noi stessi – gli umani – come maggioranza al potere?
Se vogliamo comprendere in modo privo di pregiudizi e distorsioni la realtà, allora estendere il discorso oltre l’essere umano, oltre la nostra specie, ha senso.
Anche come retaggio di una visione positivista dell’evoluzione, noi pensiamo alla nostra specie non come una tra le tante, ma come al culmine di un processo di perfezionamento della natura. Se vogliamo ridurre lo squilibrio di potere esistente tra maggioranza e minoranze, un punto di partenza è sicuramente fare nostro il concetto di biodiversità e applicarlo anche alla visione che abbiamo di noi stessi in quanto specie dominante. Forse questo potrebbe aiutarci a comprendere che la diversità è insita nella natura stessa delle cose.
[1] F. Acanfora, In altre parole. Dizionario minimo di diversità, effequ, 2021, p. 103.
[2] Ivi, p. 121.
[3] Ivi, p. 126.
[4] Ivi, p. 133.
[5] www.cbt.int/convention/articles/?a=cbd-02. Citato in Acanfora, In altre parole, cit., p. 95.




