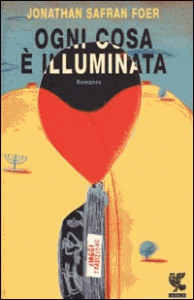La prima volta che ho incontrato Jonathan Safran Foer avevo sedici anni, e quello che ho provato per lui è stato un sentimento molto simile all’amore.
C’era stata un’eclissi lunare totale pochi giorni prima, la Repubblica Popolare Cinese aveva appena riconosciuto il diritto alla proprietà privata, e io aspettavo una primavera piena di voglie nuove. Avevo preso Ogni cosa è illuminata quasi per capriccio, a tre anni di distanza dalla sua prima pubblicazione, e ne ero rimasta folgorata.
Perché è serio e insieme divertente, innanzitutto, ch’è una combinazione rarissima in un romanzo («Il buffo», fa dire Foer a uno dei suoi personaggi, «è l’unico modo veritiero per raccontare una storia triste»).
Perché è un libro che ha un profumo proprio, come le case dei nonni, i dopobarba dei papà e le persone a cui vogliamo bene quando le abbracciamo (ma non solo: è un libro pieno di persone, di oggetti, di ricordi, di voci e, persino, di storie, che vuol dire, in una sola parola, pieno di vita).
E poi, soprattutto, perché ha una prosa che sembra in grado, in ogni momento, di cambiare pelle, e che racconta la realtà come un ciclo di improbabili mutazioni in cui tutto può trasformarsi e subito tornare com’era.
Avevo capito qualche settimana dopo, ascoltando in un giorno triste Anthem di Leonard Cohen (ebreo non osservante come Foer), quanta poesia e quale poetica ci fosse in Ogni cosa illuminata.
There’s a crack in everything / that’s how the light gets it (“C’è una crepa in ogni cosa / è così che entra la luce”), cantava Cohen con la sua voce baritonale, e io riuscivo a vedere la luce dietro – dentro – le seicentotredici tristezze di Brod, nel mondo spietato fragile meraviglioso terribile raccontato da Foer. Un mondo in cui non c’è luce e non c’è Dio, ma in cui ogni cosa è cosa illuminata, portatrice di luce.
A dirlo nel romanzo – con altre parole – è proprio Brod: «Ogni amore è scolpito nella perdita. Il mio lo è stato. Il tuo lo è. Lo sarà quello dei tuoi pro-pro-pronipoti. Ma noi impariamo a vivere in quell’amore». Da allora me lo sono ripetuta tutte le volte che è servito. Quando mi ha lasciata e non è successo niente; quando io ho lasciato e non è successo niente; quando me ne sono andata da Bologna. Ed è servito.
Sono passati undici anni – più o meno (più, sob) – dal giorno in cui ascoltavo Anthem, e oggi ho la stessa età che aveva Foer quando ha pubblicato il suo primo, “illuminato” romanzo. Nel mezzo ci sono state altre due opere di Foer: Molto forte, incredibilmente vicino e Se niente importa. Il primo narra le peregrinazioni di un bambino di nove anni, in una New York post 11 settembre, alla ricerca del padre scomparso nell’attentato alle Torri Gemelle. Il secondo è un saggio di denuncia contro l’industria della carne che tenta di rispondere raccontando l’evidenza a una sola domanda: perché mangiamo gli animali?
Nel mezzo, per me, ci sono stati, in ordine sparso: tre traslochi, una laurea, 4 stipendi, un coniglietto domestico, innumerevoli gioie, alcuni tagli di capelli sconsiderati, tanti pensieri buoni che non sempre si sono tradotti in buoni pensieri. Eppure, due cose sono esattamente come allora: continuo a innamorarmi degli stessi due tipi di uomini (quelli già morti e quelli immaginari) e mi ritrovo a leggere un romanzo di Foer in ritardo.
Il romanzo in questione è Here I am (“Eccomi”, in italiano), e prende il titolodall’hinneni pronunciato da Abramo in un famoso episodio della Genesi. Quando Dio chiama Abramo per ordinargli il sacrificio del figlio Isacco, Abramo risponde “eccomi”. Ma risponde “eccomi” anche al figlio Isacco che, raccolta la legna e appiccato il fuoco, gli chiede dove sia l’agnello da sacrificare. E come può, Abramo, essere contemporaneamente l’uomo che si affida a Dio senza riserve e il padre che protegge il figlio? Questo è il dramma che anima Jacob Bloch, il protagonista del romanzo, che vorrebbe dire “eccomi” alla sua famiglia, mentre l’ordine familiare sta collassando, ma sente di dover dire “eccomi” anche davanti alla Storia che – come nei primi due romanzi –fa da sfondo: il terremoto spaventoso che ha devastato Israele.
C’è tanto da dire su questo romanzo – tradotto (bene) da Irene Abigail Piccinini – che Foer ha impiegato undici anni a scrivere, ma due cose mi sembrano particolarmente importanti in questo romanzo, più due piccine che pure mi paiono indicative del talento di Foer.
La prima è che Eccomi è un romanzo che respira, che indaga in maniera limpida e straordinariamente dettagliata il rapporto tra gli esseri umani. Nessuno dei personaggi del microcosmo Bloch riesce a dire “eccomi” all’altro: non Julia, non Jacob, non i loro tre figli maschi (su tutti Sam), non i nonni. Nessuno si affida all’altro con la stessa nuda vulnerabilità con cui Abramo si offre a Dio; nessuno è presente all’altro senza riserve, condizioni, bisogni. Eppure, nessuno è cattivo. Questa, sembra dire Foer, è la condizione di tutte le famiglie borghesi in Occidente, famiglie infelici che – per smentire Tolstòj – si somigliano tutte. Nelle piccole miserie di ogni giorno, nei sotterfugi, nelle frustrazioni, nei desideri erotici, nei silenzi annoiati, nelle vite che scorrono come le immagini delle catastrofi in TV, le stesse davanti alle quali restiamo indifferenti continuando a mangiare il nostro pollo. In questo senso, Eccomi è innanzitutto una magistrale rappresentazione della vita della classe media occidentale ai giorni nostri, che sa dire “eccomi” a null’altro che a se stessa.
La seconda è che volendo isolare i temi del romanzo, si sceglierebbero il sesso, l’amore, la religione e soprattutto l’identità. L’identità, ch’è l’identità ebraica, costituisce infatti la seconda colonna portante del romanzo. A incarnare «il sentimento di essere ebreo» nel romanzo ci sono i parenti d’Israele, il nonno, Jacob e Julia, ma soprattutto Sam, il maggiore dei tre figli della coppia Bloch, che vive in maniera conflittuale il rapporto con l’ebraismo. Il suo sentimento è una commistione di desiderio, senso di solitudine, paura, vergogna. Ma, si puntualizza, «Sam non era davvero nessuna di queste cose né la loro somma», come a dire che, qualunque sia lo sforzo, spiegare l’identità ebraica è impossibile, come spiegare un sentimento. Foer abbozza l’identità ebraica con una tale semplicità, pur senza semplificare un tema tanto complesso, che supera su molti aspetti Saul Bellow, Bernard Malamud e i fratelli Singer.
E poi, due dettagli trascurabili, ma emblematici della grandezza di questo romanzo-mondo.
1) Foer ha trovato un modo per rappresentare l’interruzione improvvisa delle nostre esistenze causata dall’arrivo di un sms o di un messaggio whatsapp. Il modo consiste nell’inserire, tra le righe di un discorso logico, di un dialogo sensato, delle frasi che non c’entrano niente. Il lettore ci mette un po’ a capire che a dirle, anzi scriverle, è l’amante virtuale di Jacob, poi il contesto lo chiarisce. Si tratta di una soluzione efficiente e semplice, mai sperimentata finora nella forma-romanzo.
2) Eccomi è un romanzo lungo: sono 661 pagine, molte di dialogo (una modalità narrativa nuova per l’autore), moltissime di discorso indiretto libero. Eppure, Foer non ha scritto una pagina di troppo. Nemmeno una. Di quanti autori sapreste dire lo stesso senza il timore di sbagliarvi?
Io di pochi altri, e sono tutti morti.
Jonathan Safran Foer, invece, è vivo, vivissimo, e io l’ho incontrato davvero: al teatro Franco Parenti di Milano, il primo settembre del 2016.
Quello che ho provato è stato un sentimento uguale all’amore.