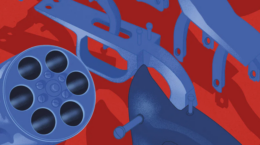Un tomo contenuto e compatto, un libro consigliatissimo: al pubblico compare così, Trilogia della Città di K., e compare un po’ dappertutto, ormai, da quando Agota Kristof è venuta a mancare. Le librerie italiane si accorgono quasi sempre tardi, quando c’è in giro un testo di valore. Solo nell’ultimo anno, la Trilogia ha cominciato ad affacciarsi alle vetrine, allo scaffale de “l’editore consiglia”, in qualche angolo nelle pagine delle riviste. La gente ha cominciato a comprarlo. E prima di comprarlo, chiede: “Ma questo libro, esattamente, di cosa parla?”.
Il ventaglio di risposte è ampio – a cominciare dal fatto che il libro non è uno, ma sono tre. Di cosa parla, Trilogia della città di K., unico testo lungo e capolavoro della Kristof? Della guerra. Della solitudine. Dell’infanzia. Della fuga. Della malattia. Di cose troppo reali, di altre inquietantemente false. Di due bambini troppo uguali tra loro, che diventano due adulti troppo distanti. O anche, di ciò che è vero, e di quello che avrebbe potuto essere vero.
In realtà, la storia è molto semplice. Due gemelli, una guerra, una frontiera improvvisamente tra di loro, di tutto il resto si occupa il tempo che passa. Ma la risposta più corretta da dare a un aspirante lettore, a mio parere, non è contenuta in questa prima impressione, va cercata nell’impianto narrativo del testo, e nell’intera opera della Kristof: la Trilogia parla della scrittura.
Agota Kristof non ha vissuto come avrebbe voluto. Sarebbe voluta nascere maschio, come i suoi fratelli, avrebbe voluto scrivere e leggere sin da quando era bambina, invece di trovarsi rinchiusa in un collegio, avrebbe voluto vivere in Ungheria, ma ha passato la maggior parte della sua vita in Svizzera. I personaggi da lei creati per la Trilogia incontrano la stessa sorte, e tutto ciò in cui credono può essere riassunto in ciò che Claus, uno dei gemelli, risponde quando gli viene chiesto se scrive storie vere, o storie inventate:
«Le rispondo che cerco di scrivere delle storie vere, ma, a un certo punto, la storia diventa insopportabile proprio per la sua verità e allora sono costretto a cambiarla. Le dico che cerco di raccontare la mia storia, ma che non ci riesco, non ne ho il coraggio, mi fa troppo male. Allora abbellisco tutto e descrivo le cose non come sono accadute, ma come avrei voluto che accadessero.»[1]
I gemelli protagonisti della Trilogia, proprio come la Kristof, scrivono storie, per metterle al posto di una vita troppo dolorosa per essere accettata. Anche Tobias, protagonista di Ieri, brevissimo romanzo della Kristof, scrive storie. E la Kristof stessa, che prende le parti dell’io-narrato dentro la sua autobiografia, L’analfabeta, cede il ruolo di protagonista della sua vita alla scrittura.
Questo legame viscerale con l’atto stesso di scrivere, di narrare, di creare realtà alternative, è presente nell’autrice fin dalla prima infanzia, e sviluppa una resistenza monolitica nella formazione della Kristof come scrittrice: l’analfabeta, si definiva lei stessa, perché per poter continuare a scrivere, dovette fare i conti con una lingua sconosciuta. Il francese, amato, per la sua utilità nel momento della diffusione del testo, ma odiato, perché straniero, perché imposto, perché inafferrabile, porta la Kristof a dare un’attenzione del tutto particolare al proprio stile. La porta a ricominciare. Ad essere allieva dei temi di sua figlia, che frequenta le scuole elementari, la costringe a distruggere ciò che aveva imparato in ungherese sullo scrivere, e a copiare con pazienza le semplici frasi scritte da una bambina. E la porta a capire che non padroneggerà mai quella lingua come uno scrittore autoctono, e capendo il limite, ha la genialità di fermarsi. La Kristof decide di scrivere l’essenziale, decide che tutto ciò che non è oggettivo non merita di rimanere sul foglio. La sua scrittura diventa un atto di cancellazione per metà, un atto di scelta. Nasce uno stile originale, immediato, adatto al testo che ha costruito, alla storia, e ai personaggi. Le frasi della Kristof passano dalla sua penna, alla penna dei meta-scrittori interni al testo, e sono di una semplicità tale che per il lettore diventa impossibile capire quando quelle frasi sono solo una bugia.
E’ uno stile inattaccabile, nella sua semplice trinità di soggetto, verbo, oggetto. Non lascia spazio a considerazioni personali, ad indizi emotivi. E’ uno stile barriera, dietro il quale è impossibile vedere dove la complicata struttura testuale sta portando il lettore. Le sorprese nascoste nella trama, allora, saltano fuori come mine su un campo totalmente vuoto.
La Kristof passa quasi l’intera vita intorno allo studio, e alla composizione della Trilogia. A scegliere una parola, in una frase che di parole ne contiene due. Il risultato, è come una piccola bomba costruita con la lente d’ingrandimento: ogni pezzo mantiene l’altro, e nessun altro pezzo potrebbe mai sostituirlo. All’interno di questa perfezione estetica, stilistica, c’è il caos. Quale tipo di caos, sta al lettore scoprirlo, ma forse non sarà sufficiente una sola lettura. Ma in fondo, come potrebbe esserlo, per un testo che ha richiesto tanta attenzione? Per la Kristof, l’ossessione per la scrittura, rende la scrittura soluzione di vita: destinata non al successo o ad una necessaria pubblicazione, destinata non ad un lettore, ma a sé stessi. Per questo, la Kristof «alla domanda su quale connessione ci sia tra i suoi romanzi e la sua vita, ha detto in modo significativo: “Sono la stessa cosa.”»[2]