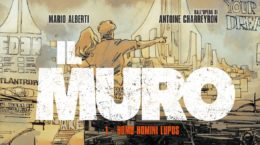Espellere i migranti climatici è contro i diritti umani. Così ha decretato a fine gennaio il comitato Onu per i Diritti Umani traendo spunto dal ricorso presentato da Ioane Teitiota, cittadino delle isole kiribati. Una sentenza dalla storica portata che spiana la strada al riconoscimento giuridico della figura del migrante o rifugiato ambientale.
La storia di Ioane inizia nel 2011 quando fa richiesta di asilo alla Nuova Zelanda dopo la scadenza del suo visto stagionale. La principale motivazione era legata ad un fondato timore di far ritorno nel suo Paese d’origine, l’arcipelago di Kiribati, dove la sua casa era stata ripetutamente distrutta da una serie di mareggiate particolarmente violente. Le Isole Kiribati, infatti, con i loro tre metri di elevazione massima sono fortemente esposte agli effetti dei cambiamenti climatici, tra i quali innalzamento del livello dei mari, erosione costiera, alte maree, cicloni e salinizzazione dei suoli. Le istituzioni e gli abitanti di Kiribati, pur essendo tra i meno responsabili, si confrontano da anni con le conseguenze della crisi climatica globale. I progetti di adattamento in loco si moltiplicano di anno in anno ma l’inevitabilità dello spostamento sembra farsi sempre più un’inquietante realtà. Sebbene la mobilità sia parte integrante della storia, della cultura e delle strategie di resilienza di molte popolazioni insulari del Pacifico, gli effetti sempre più visibili dei cambiamenti climatici fanno sì che la migrazione stia diventando una misura non desiderata ma sempre più necessaria.

Non mancano, infatti, scenari apocalittici che ritraggono gli atolli del Pacifico come già dati per spacciati e che ne predicono la totale sommersione nell’arco di qualche decennio. C’è chi è più cauto e sposta la lancetta dell’orologio alla fine di questo secolo. In ogni caso, sembra non vi sia spazio per un altro epilogo. Da tempo ormai esistono accordi bilaterali tra gli Stati insulari del Pacifico, l’Australia e la Nuova Zelanda per favorire la mobilità lavorativa e garantire il rinvio di rimesse. Questi potrebbero essere implementati al fine di costituire anche un supporto alla mobilità per cause climatiche. Da qualche anno, inoltre, la Nuova Zelanda discute la possibilità di istituire un tetto massimo annuale di visti umanitari da riconoscere a chi è costretto a spostarsi a causa del progressivo degrado ambientale. Questa misura andrebbe a colmare un gap normativo e riconoscerebbe un determinato status, quindi dei diritti, a coloro che ne fanno richiesta. Tra questi, Ioane Teitiota è stato il primo al mondo a fare appello alla Nuova Zelanda al fine di ottenere lo status di rifugiato climatico e poter riunire, così la propria famiglia. Dal 2011, tuttavia, la battaglia legale volge al termine dopo quattro anni senza esiti positivi. La Nuova Zelanda, infatti, scrive che sebbene vi sia un pericolo legato all’innalzamento del livello dei mari, questo non può essere prontamente dimostrato e non rappresenta sufficiente motivazione per il riconoscimento dello status di rifugiato. La ragione, tuttavia, è simile a chi fa richiesta di asilo per motivi politici o religiosi: il timore di tornare nel proprio paese a causa di possibili persecuzioni. Gli effetti dei cambiamenti climatici, infatti, costituiscono una minaccia per la sicurezza e il diritto alla vita e possono essere intesi al pari di una persecuzione. Secondo il Dipartimento dell’Immigrazione della Nuova Zelanda, tuttavia, nel 2015 Teitiota e la sua famiglia non risultavano esposti a gravi danni e non vi era indicazione secondo cui il governo di Kiribati mancasse di adottare le misure necessarie alla loro protezione. Con questa sentenza, la Nuova Zelanda blocca di fatto la possibilità per Ioane e la sua famiglia di ricostruirsi una vita più sicura, contemporaneamente esplicitando il fatto che la protezione dei propri cittadini è affare esclusivo del singolo Stato, ignorando le precise responsabilità e la trasversalità propria della natura dei cambiamenti climatici. A gennaio di quest’anno, tuttavia, in seguito al ricorso presentato al Comitato ONU per i Diritti Umani nel 2016, la sentenza è stata soggetta a revisione. Teitiota, infatti, ha aggiunto che nel corso degli anni le tensioni legate alla terra e alla scarsità idrica, sono aumentate a tal punto da impattare sulla quotidianità e sulla sicurezza della sua famiglia residente nella sovrappopolata capitale Sud Tarawa.

Pur non rappresentando una vera e propria svolta per la vita di Ioane – la decisione della Nuova Zelanda non vìola alcun codice o regolamento internazionale in quanto la sua vita non era in immediato pericolo -, la sentenza del Comitato ONU riconosce per la prima volta ufficialmente la rilevanza che il cambiamento climatico ha nel rappresentare una minaccia al diritto alla vita. Questo fa sì che in futuro, i singoli Stati saranno costretti a considerare gli effetti del climate change come una motivazione valida per concedere al richiedente di restare, evitando, dunque, il rimpatrio. La decisione, come spiega la ricercatrice e attivista di Amnesty International, Kate Schuetze, è senza precedenti e traccia un segno importante poiché, in sostanza, afferma che uno Stato violerebbe gli obblighi di rispetto dei diritti umani se solo tentasse di rimpatriare qualcuno in un Paese altamente vulnerabile ai cambiamenti climatici, in cui la vita potrebbe essere a rischio o in pericolo di “trattamento crudele, disumano o degradante”. Per la prima volta, il principio di non-refoulment viene ribadito in riferimento alla crisi climatica globale e si afferma esplicitamente che ogni Stato ha l’obbligo di proteggere le persone dai dannosi effetti dei cambiamenti climatici, compreso lo sfollamento. Questa sentenza potrebbe costituire uno strumento giuridico prezioso al quale appellarsi per le richieste d’asilo legate alla crisi climatica. Sebbene si tratti di una decisione per ora non vincolante che non deve affatto distogliere l’attenzione dalla necessità di adottare misure di mitigazione immediate, più incisive ed efficaci, la decisione del Comitato ONU per i Diritti Umani lascia un segno indelebile e lancia un messaggio chiaro: occorre agire preventivamente anche in relazione alla mobilità umana. Non c’è bisogno, infatti, che gli stati insulari del Pacifico finiscano sott’acqua per far sì che gli Stati si rendano conto dei loro doveri di tutela del diritto alla vita, ancora troppo spesso vìolato in troppe regioni del mondo.
Phcredit: www.adaptation-undp.org, www.gi-escr.org, www.greenme.it