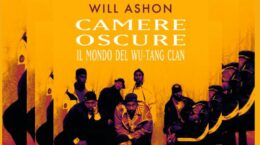Risulta ormai trito l’interrogativo sullo stato dell’arte ai giorni nostri, nel nostro Paese e nella nostra epoca i confini tra ciò che è arte e intrattenimento commerciale sono diventati così labili da sfilacciarsi in tutti i campi della società, così per molti la parola arte può essere indiscriminatamente associata a manifestazioni figurative, allo sport, alla pubblicità fino ad investire anche la politica. In questa incertezza sul termine “arte” e nello sciame di categorie e definizione che ormai utilizziamo per tutto ciò che ci circonda perdendone il significato – proprio come una parola ripetuta un certo numero di volte ci appare senza senso – ci ritroviamo a che fare con le nostre sensazioni e la nostra capacità di riuscire ancora a riconoscerle per quello che sono.
Proprio sensazioni ed emozioni si intrecciano raramente in modo così profondo e florido come nel teatro d’opera dove musica e parole si rincorrono in uno spumeggiare di trepidazioni, una rappresentazione questa che per quanto antiquata e spesso tacciata di anacronistica pesantezza, non cessa di richiamare pubblico, anche se si tratta di un pubblico spesso sconosciuto. Per conoscere più a fondo questo mondo ci siamo rivolti a chi ne ha sperimentato entrambe le facce: dapprima quella dello spettatore, seduto tra platee e loggioni; poi quella dell’interprete, sul palco, tra le luci e di fronte agli invisibili volti del pubblico.
Abbiamo incontrato Mario Cassi, affermato baritono e da sempre amante appassionato dell’opera alla quale ha dedicato un instancabile e gioiosa schiavitù che lo ha portato a collaborare con le eccellenze di questo mondo dove sovraneggiano musica e parola, da Riccardo Muti a Zubin Mehta, da Luca Ronconi a Plácido Domingo calcando le scene di tutto il mondo nei panni di Figaro o Papageno.
 In un mondo come quello della lirica come si considera un interprete, o meglio, come ti consideri tu stesso?
In un mondo come quello della lirica come si considera un interprete, o meglio, come ti consideri tu stesso?
Io mi potrei definire un operaio dell’arte. Questo perché il nostro è un lavoro che al pubblico e agli addetti ai lavori può apparire come un prodotto finito che sembra cadere dall’alto, mentre in realtà quello che è il risultato finale sottoposto all’apprezzamento del pubblico, al giudizio, all’amore o al disprezzo, è il frutto di un grande impegno che non si riduce al mese, quaranta giorni o più delle prove, ma si estende a tutti gli anni in cui hai lavorato per costruire un personaggio, per adattare uno spartito alla tua vocalità, per adattare la tua vocalità a uno spartito. È un lavoro di studio, di costruzione e per questo qualcuno è veramente come un operaio; è necessario lavorare sul corpo, sulla voce, sulle intenzioni, sulle emozioni, tutto ciò per fare quello che dovrebbe essere il nostro lavoro, ovvero regalare delle emozioni al pubblico.
In questo senso, anche pensando a quando ero io a far parte pubblico, sono convinto che i momenti più grandi siano quando tutte le file di spettatori vengono invasi da una forte emozione che arriva come una vera scarica di adrenalina, qualcosa che provi solo in quel momento aggrappato alla tua poltrona, e te l’ha comunicata gli artisti sul palcoscenico. Fare qualche cosa che colpisca davvero, da parte mia io ho lavorato tanto per arrivare a questo.
E l’emozione che l’artista trasmette come credi che possa legarsi a quella del pubblico?
Secondo me lo spettacolo – nel mio caso l’opera in particolare, ma un po’ tutte le performing art, le rappresentazioni dal vivo – non sono fatte per il pubblico; noi non siamo come la televisione o come il cinema dove il pubblico è materialmente separato da uno schermo, la rappresentazione si fa insieme al pubblico e di questo sono sempre più convinto. Quindi è evidente che le emozioni arrivano al pubblico e da lì tornano a noi dandoci nuova carica, è una continua risonanza, o uno scambio come una partita di tennis. Infatti se il pubblico manca, se il teatro non è pieno o non tutti hanno voglia di fare questo tipo di ascolto attivo, la serata decolla diversamente e finisce per avere un differente esito; inutile dire che le più belle serate sono quelle in cui c’è questo reciproco scambio da cui scaturisce un vero crescendo emotivo.
Per capire l’importanza del suono e della sua natura dobbiamo pensare che specialmente per la voce – per tutta la musica in realtà – il suono non esiste in noi ma esiste solo nel momento in cui lo proiettiamo fuori di noi e qualcuno lo ascolta, se non c’è nessuno ad ascoltare è come se non esistesse nulla. Io quando studio devo lavorare molto da solo ma sento sempre il bisogno di qualcuno che ascolti, che mi guidi, mi corregga e mi stimoli.
Adesso ad esempio è diventato di moda aprire la prova generale al pubblico, un pubblico generalmente di giovani e studenti, e queste sono serate bellissime perché tutti quanti gli artisti coinvolti danno molto di più quando c’è qualcuno che ascolta, nessuno escluso. Quando sei in casa da solo a cantare studi, ti ascolti e tutto il resto ma non è la stessa cosa… Manca l’elemento fondamentale, l’essenza stessa della voce, del suono, qualcuno che lo senta.
Parlando della tua esperienza personale, scopristi di avere una dote, una voce particolare, o partisti dalla passione per la lirica per poi affinare gli strumenti?
Per questo dovrei tornare così indietro nella memoria che mi troverei come chi si chiede se sia nato prima l’uovo o la famosa gallina. Mi ricordo che quando mi chiesero, nella mia prima intervista dopo un riconoscimento importante, come un giovane potesse scegliere un tipo di attività così poco considerata dai coetanei, io risposi che questo mestiere – è un’arte ma soprattutto un mestiere – non lo scegli tu ma è lui a sceglierti. Io devo dire di aver avuto la fortuna di coronare tantissimi sogni tanto da voltarmi indietro a volte e chiedermi se per caso, pensando da dove sono partito, non mi trovi in un lunghissimo sogno dal quale prima o poi doversi svegliare.
Questo sogno però è partito da qualcosa, in spagnolo c’è una parola che la definisce, duende; è una specie di spirito che avverti in te e se lo senti insisti a seguire la strada che ti indica, contro tutto e contro tutti. I primi tempi ammetto che è stato difficilissimo, venendo da una famiglia di laureati in cui mio padre, libero professionista, e gli altri consideravano la musica poco più di un passatempo e non certo un lavoro. Senza quindi alcuna tradizione per cui qualcuno mi potesse appoggiare mi mettevano in guardia dai rischi che vedevano nel teatro – senza per altro mai averlo conosciuto – come le incertezze e tutte le difficoltà che può immaginare chi vive dei racconti che si vedono nei giornali, pensando sicuramente che sarebbe stato complicatissimo poter fare questa carriera. Perciò mi laureai a ventitré anni in economia a Firenze, però con una tesi sulle fondazioni liriche e il futuro delle performing art, a riprova di come anche in ambito economico restassi comunque ancorato all’ambito di quello che rimaneva il mio sogno professionale e la mia passione.
Prima di questo però il mio duende non era rimasto inattivo, volendo ripercorrere tutta la cronistoria potrei dire che il suo risveglio avvenne a scuola, facevo la terza media e la professoressa cominciò a farci sentire delle opere, la prima fu il Barbiere di Siviglia con la Callas e Tito Gobbi, da allora comincia ad appassionarmi al mondo dell’opera. Quando seppi che avrebbero dato alla Rai una serata alla Scala, al tempo erano veri e propri eventi, subito mi collegai. Era il 7 dicembre dell’86, avevo tredici anni ed ero in camera mia con una piccola televisione in bianco e nero mentre la grande a colori in salotto era occupata da mio padre e mio fratello, lì vidi il Nabucco diretto da Riccardo Muti con il famoso bis del coro in quella che fu una serata indimenticabile. Mi ero premunito anche di un registratore audio e credo di avere ancora da qualche parte la cassetta.
 Fino a quel momento avevo creduto che l’opera esistesse soltanto nei dischi e la scoperta del teatro per me fu una rivelazione, così in occasione di un “ottimo” in terza media mi feci portare dai miei genitori a vedere il mio primo spettacolo dal vivo, fu all’Arena di Verona, l’Aida, e fu un emozione talmente forte che ci volli tornare due settimane dopo. Così cominciò la mia dipendenza, quello stesso anno vidi al teatro Petrarca di Arezzo, oggi ahimé da tempo chiuso, la mia prima opera a teatro, il Barbiere di Siviglia con Anna Caterina Antonacci ed Ernesto Palacio. L’anno dopo, altra grande rivoluzione, scopro il Maggio Musicale Fiorentino ed è lì che la mia passione è cresciuta a dismisura.
Fino a quel momento avevo creduto che l’opera esistesse soltanto nei dischi e la scoperta del teatro per me fu una rivelazione, così in occasione di un “ottimo” in terza media mi feci portare dai miei genitori a vedere il mio primo spettacolo dal vivo, fu all’Arena di Verona, l’Aida, e fu un emozione talmente forte che ci volli tornare due settimane dopo. Così cominciò la mia dipendenza, quello stesso anno vidi al teatro Petrarca di Arezzo, oggi ahimé da tempo chiuso, la mia prima opera a teatro, il Barbiere di Siviglia con Anna Caterina Antonacci ed Ernesto Palacio. L’anno dopo, altra grande rivoluzione, scopro il Maggio Musicale Fiorentino ed è lì che la mia passione è cresciuta a dismisura.
Marinavo il liceo, volendomi dedicare interamente all’opera mi facevo interrogare il prima possibile per poi andare a passare due intere giornate a Firenze, per quello che per me era diventato un vero e proprio evento. Nell’89 il Maggio dava tre opere con cast fantasmagorici, Pelléas et Mélisande di Debussy, Idomeneo di Mozart e I Puritani di Bellini al Comunale in cui figurava come coprotagonista Luciana Serra e le scene erano opera di De Chirico; dopo quella serata del 31 maggio dell’89 uscì fuori dal teatro… quasi traumatizzato. L’opera ormai per me era diventata, non so come dire, quasi una droga, ma anche di più; quando arriva quell’emozione e sai che la puoi provare soltanto grazie a questo… è qualcosa di così affascinante ed inspiegabile.
In un libro di Alfred Tomatis, L’Orecchio e la Voce, si parla del potere che ha la voce sulla corteccia cerebrale umana di chi ascolta e pare che tra tutti i suoni sia quello che scatena le emozioni più forti, a volte incontrollabili. Al di là delle implicazione neurale, per me l’opera era diventata il pensiero dominante e allora decisi che sarei voluto restare a tutti i costi in quel mondo; iniziai a studiare pianoforte, tardissimo, e non sapevo se avessi una voce adatta o altro, mi dicevo soltanto che sarei voluto esser parte in quello che avevo visto e sentito.
Dal pianoforte mi mandarono a fare una lezione di canto ed è lì che ha avuto inizio il lunghissimo lavoro che continua ancora oggi, c’è voluta molta pazienza e io in particolare ho sempre preferito lo studio all’esibizione: la preparazione, il momento creativo; quando hai bravi registi o direttori d’orchestra, il momento delle prove è bellissimo, crei veramente qualcosa e si lavora tanto sul dettaglio, su un passaggio, una sfumatura, un’idea…quello è ancora oggi il momento che preferisco, che più mi stimola e mi fa crescere. Ripeto, noi lavoriamo per dare un’emozione e io non ho mai creduto agli artisti che si commuovono mentre cantano; credo che il nostro compito sia far piangere non essere noi a piangere, noi dobbiamo emozionare e per me è fondamentale il controllo, soprattutto per un arte come la nostra che si basa su una tecnica per cui un emozione che altera il respiro può rovinare una frase, e non sempre una frase rovinata per un emozione regala un altra emozione.
Quindi c’è un reale apporto creativo da parte dell’interprete, o si parla solo di modificazioni in rispetto delle indicazioni dello spartito facendo del cantante un raffinato e competente esecutore?
Prima di tutto dipende da compositore a compositore, storicamente non è bello generalizzare: ad esempio Mozart era un compositore che aveva scritto tutto, però indiscutibilmente le indicazioni da parte dei compositori sono aumentate col passare dei secoli – Puccini ad esempio, così come anche Wagner, scrivevano persino dettagli di regia. Detto ciò la musica, per chi la sa veramente leggere, avrebbe già in sé potenzialmente tutto quanto; ma la vera bellezza dell’opera e ciò che la può ancora far risuonare attraverso i secoli, è proprio il suo essere aperta alle interpretazioni. Questa è la questione basilare e, a mio avviso, sempre tenuta poco presente: il fatto che la voce umana sia l’unico strumento irriproducibile per cui, se è difficile ma non impossibile trovare due oboi, o due timpani che abbiano un suono pressoché identico, due baritoni con la stessa voce non sono mai esistiti né potranno mai esistere nella storia.
Dobbiamo pensare che tutti questi compositori non scrivevano le loro opere pensando a un personaggio storico o immaginario ma al cantante che avevano prediletto o che era a loro disposizione; se questo da una parte ci obbliga a riconoscere che non si potrà mai riprodurre “l’originale”, per quanto qualcuno ci abbia provato, dall’altra ci dovrebbe far capire la bellezza dell’opera oggi: una voce nuova che canta un ruolo con le stesse note e le stesse sfumature è ciononostante qualcosa di nuovo, di diverso e quindi degno di mantenere viva l’attenzione. Questo è un argomento fondamentale che purtroppo invece molti, tra gli addetti ai lavori così come tra il pubblico, tendono ad evitare preferendo legare il ruolo a un cantante di riferimento – della storia o del presente – che deve essere considerato un modello assoluto da seguire.
Per me è un grave errore. Penso alle recensioni del passato, dei tempi di Bellini e Donizetti, quando non si diceva « la Malibran è stata una grande Norma » ma dicevano « la Malibran è stata straordinaria in tali e tali passaggi ». Il ruolo veniva totalmente identificato col cantante e questo oggi è impensabile perché ci considerano esclusivamente interpreti, questo non perché prima ci fosse maggiore divismo – anzi ai giorni nostri il divismo, nel suo lato peggiore, è ancora più accentuato – è piuttosto cambiata la prospettiva. Io, ripeto, sono sempre al servizio della musica e del testo e trovo orrendo quando si forza un personaggio per adattarlo a sé, però è anche vero che una volta il cantante riceveva molta più attenzione, nell’800 e anche nei primi del ‘900 si andava a teatro a sentire i cantanti più ancora che l’opera.
Ovviamente non possiamo pensare all’opera come a un concerto di cui siamo padroni e protagonisti assoluti: la prassi esecutiva e il rispetto dei valori musicali per me è fondamentale, così come i valori teatrali del personaggio per la regia. Piuttosto sostengo il valore, proprio per rendere giustizia all’opera come teatro in musica e al pensiero di grandi autori come Mozart, Verdi, Donizetti, dell’interpretazione, di un cantante che non sia solo un esecutore, ma un musicista e un attore che può dare il suo apporto personale, distinguersi nella sua lettura per le sue caratteristiche uniche.
Per questo, quando vedo l’approccio che si ha nei riguardi del teatro ai giorni nostri, mi sembra di registrare una svalutazione del concetto stesso di rappresentazione teatrale, ovvero sembra che ultimamente si vada a teatro con lo stesso spirito con cui si va al cinema nonostante il grandissimo lavoro compiuto negli anni Settanta e Ottanta da direttori come Muti o Abbado per cancellare il divismo e riportare l’attenzione ai valori del testo cosicché l’opera tornasse ad essere non un’esibizione estemporanea ma una rappresentazione di valore artistico.
Oggi però – è una mia impressione che credo di percepire vivendo dentro a questo insieme di cose e persone – si registra un’eccessiva riduzione dell’individualità per cercare a tutti i costi di omologare, un’omologazione che ha origine in una vera e propria classificazione; si tende così a costruire delle categorie ben definite con lo scopo di facilitare la scelta. Avremo dunque il soprano lirico, il soprano leggero, il soprano drammatico; il baritono brillante, il baritono drammatico eccetera, definizioni che in realtà non sono altro che una serie di omologazioni tendenti a ridurre l’individualità e la personalità di ciascun artista.
Rispetto agli anni Ottanta e Novanta le cose sono cambiate, si è sviluppata questa tendenza all’omologazione che è veramente la morte dell’arte lirica, se la vogliamo considerare come espressione tramite voce di emozioni scritte dai più grandi musicisti della storia, emozioni che noi dobbiamo far rivivere oggi materialmente grazie al nostro corpo. Invece di sfruttare le proprie differenze per dare nuovo colore all’opera si preferisce non valorizzare le singolarità – ovviamente, inutile ribadirlo, questo non vale per tutti i registi o direttori d’orchestra – però questa è una situazione che nell’attualità sembra valere in vari ed estesi ambiti della vita e non semplicemente nell’arte.
E la situazione dei teatri, tra le persone che vi lavorano e vivono insieme, è in qualche modo mutata?
Attualmente il problema è di livello organizzativo, la crisi ha creato una nuova tensione all’interno e anche verso l’esterno, ci sono persone che da due mesi non prendono lo stipendio pur lavorando continuamente nell’incertezza per il futuro e per il presente temendo che il percorso artistico di una vita si possa sgretolare e diventare inutile, questo mentre intere entità artistiche vengono semplicemente cancellate. In fondo il teatro è come una famiglia, un’azienda certo ma familiare, e anche soltanto girando per i corridoi si sente questo cambiamento di clima.
Se tu dovessi assistere a una stessa opera partendo dalla Germania e arrivando in Italia passando per Vienna vedresti tre opere completamente diverse, non solo per il tipo di approccio registico o di allestimento ma soprattutto per il pubblico; all’estero gli spettatori sono molto più numerosi e determinati ad ascoltare veramente l’opera e non è questione di minore difficoltà a potersi permettere l’ingresso perché i biglietti costano meno in Italia che, ad esempio, in Spagna.
Perciò io in primo luogo preferisco parlare di una crisi di valori piuttosto che di una crisi culturale: senza una chiara scala di valori risulta difficile riconoscerli bene e di conseguenza compiere delle scelte; in secondo luogo noi operatori del settore dovremmo farci in prima persona delle domande, quando ci sono poltrone vuote o scarso interesse mi dico sempre che evidentemente siamo anche noi a sbagliare qualcosa ma, purtroppo, a questa autocritica viene spesso preferito il classico gioco dell’addossare le proprie responsabilità sugli altri.
La crisi dunque è generale e basta poco a far fallire una o una serie di rappresentazioni. Magari lo spettacolo ha dei punti deboli, o è stato mal scelto e non attira spettatori oppure non è stato ben pubblicizzato; carenze d’interesse da parte del pubblico ci sono sempre state però quando si ripetono frequentemente nello stesso teatro vuol dire che c’è qualcosa che non funziona, dentro e fuori.
Tornando al ruolo di artista creativo, personalmente come lo vivi in questo momento della tua carriera?
Io, ogni volta che riprendo un ruolo, lo ristudio e cerco di trovare qualcosa di nuovo nelle pieghe dello spartito e la cosa più bella che sto notando ora, dopo tredici anni dal mio debutto con un ruolo importante, è che rivestendo più volte certi ruoli cominci a sentire la padronanza della voce e avverti che non devi più pensare principalmente ai problemi vocali o tecnici ma ti rendi tangibilmente conto che la parte è entrata dentro di te; tutto allora scaturisce naturalmente, facilmente, permettendoti di diventare davvero un malleabile strumento nelle mani tue, del direttore e del regista. Questo è dovuto principalmente alla maturità, alle soglie dei quarant’anni sento di essere padrone dei miei mezzi vocali, grazie al continuo lavoro di studio con i miei maestri e autonomamente; anche se sicuramente per una completa maturità artistica ci sarà sempre da lavorare, è un cammino che non si ferma mai.
Ci sono stati dei momenti negli anni passati in cui la voce non faceva quello che volevo, non riuscendo a ottenere ciò che volevo era come un combattimento contro me stesso, ne ho sofferto; ora finalmente sento di potermi esprimere con la mia voce in maniera libera e naturale. Questo da una soddisfazione enorme perché mentre prima dovevo per necessità pensare a come impostare la voce prima delle prove, studiare, e prepararmi, ora c’è bisogno di molto minore struggimento perché la voce è come se fosse già pronta.
 Quando canto adesso sento il piacere di poter fare scelte di natura artistica, musicale senza preoccuparmi troppo di adattarle alle mie possibilità tecniche. Nell’esatto momento in cui sto cantando adesso non penso più, provo un piacere fisico, mentre prima l’aspetto tecnico ed esecutivo prevaleva su quello artistico; ad esempio ero meno consapevole dell’importanza di fare i colori, di dare delle intenzioni, dinamiche, crescendo, costruire un vero e proprio progetto vocale e musicale. Ma la cosa più significativa e entusiasmante di questa nuova libertà vocale è il lasciarsi la possibilità di giocare e lavorare con la parola, con il testo, di riappropriarsene. In questo lavoro si pensa sempre principalmente all’emissione e forse a volte si perde il significato di quello che diciamo.
Quando canto adesso sento il piacere di poter fare scelte di natura artistica, musicale senza preoccuparmi troppo di adattarle alle mie possibilità tecniche. Nell’esatto momento in cui sto cantando adesso non penso più, provo un piacere fisico, mentre prima l’aspetto tecnico ed esecutivo prevaleva su quello artistico; ad esempio ero meno consapevole dell’importanza di fare i colori, di dare delle intenzioni, dinamiche, crescendo, costruire un vero e proprio progetto vocale e musicale. Ma la cosa più significativa e entusiasmante di questa nuova libertà vocale è il lasciarsi la possibilità di giocare e lavorare con la parola, con il testo, di riappropriarsene. In questo lavoro si pensa sempre principalmente all’emissione e forse a volte si perde il significato di quello che diciamo.
Ricordiamo che per i primi compositori la musica è sempre nata dall’ispirazione di un testo e di un’opera si ricordava prima di tutto l’autore dei versi; poi, col passare del tempo, le note hanno prevalso sulle parole – cosa che spesso rende sconosciuti i librettisti, anche geni del calibro di Lorenzo da Ponte – e da sempre i più grandi cantanti colpiscono per la grande attenzione che danno al testo, perché noi cantiamo la parola e spesso ce ne dimentichiamo pensando solo alla bellezza del suono e alla sua difficoltà. Il punto fondamentale potrebbe sembrare allora il riuscire semplicemente a far capire perfettamente il testo ma questo non è tutto perché anche ascoltando un’opera in russo (o qualunque altro idioma a noi sconosciuto), se chi la canta sa accentare bene le parole, si riesce a capire perfettamente l’andamento della vicenda. Il problema allora è cantare così bene da rendere il tutto comprensibile fino all’ultima fila della platea perché fonicamente l’articolazione delle consonanti si perde proprio con l’aumentare della distanza.
Per questo i grandi direttori insistono sempre per un’articolazione esagerata che permetta a tutte le persone nei grandi teatri di comprendere quello che dici, per riuscire in questo devi sicuramente avere una grande mobilità della mascella, ma soprattutto devi comprendere e apprezzare il gusto di masticare la parola, di goderti la parola, cioè pensare che quello che stai cantando non è semplicemente una melodia ma sono parole in musica.