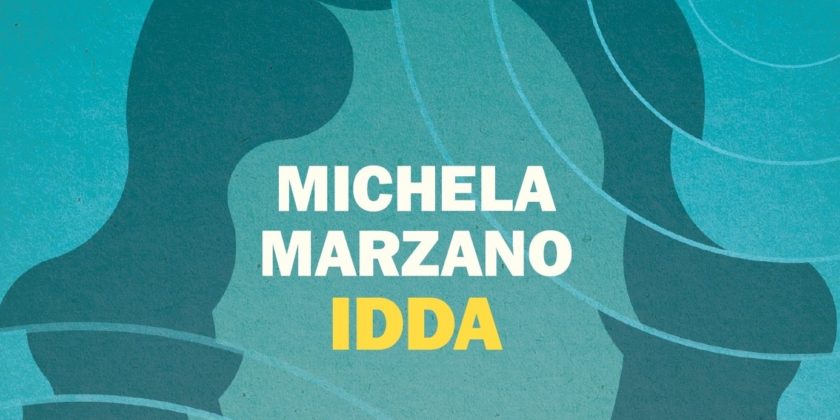«Di fronte all’inevitabile sconfitta che chiamiamo vita non ci resta che cercare di comprenderla»
– Milan Kundera
Michela Marzano ha pubblicato a gennaio di quest’anno Idda per Einaudi Stile Libero, il suo secondo romanzo, con cui è in giro con un tour di presentazione per le librerie italiane. Il romanzo è sull’identità, sulla memoria, sulla potenza delle relazioni, intrecciando le vite di due donne, Alessandra e Annie.
Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita con Pierre. Quando Annie, l’anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché sta progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in discussione standole accanto. Alessandra entra nell’universo della suocera, una stenodattilografa degli anni Quaranta, e pian piano ne ricostruisce la quotidianità, come fosse l’unico modo per sapere chi era, adesso che smarrendosi Annie sembra essere diventata un’altra.
Nel rapporto con lei, Alessandra si sente dopo tanto tempo di nuovo figlia, e d’improvviso riaffiorano le parole dell’infanzia e i ricordi che aveva soffocato. Da anni infatti non va nel Salento, il luogo in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a fare i conti con le ombre del suo passato. Bisogna attraversare le macerie, recuperare la propria storia, per scoprire che l’amore sopravvive all’oblio.
 Michela Marzano è professore ordinario di filosofia morale all’Università di Paris Descartes, editorialista de «la Repubblica» e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue. In Italia ha pubblicato, tra gli altri, “Volevo essere una farfalla” (2011), “L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore” (Premio Bancarella 2014), “Papà, mamma e gender” (2015). Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato il romanzo “L’amore che mi resta” (2017).
Michela Marzano è professore ordinario di filosofia morale all’Università di Paris Descartes, editorialista de «la Repubblica» e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue. In Italia ha pubblicato, tra gli altri, “Volevo essere una farfalla” (2011), “L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore” (Premio Bancarella 2014), “Papà, mamma e gender” (2015). Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato il romanzo “L’amore che mi resta” (2017).
«E se la parte autentica di ognuno di noi fosse nascosta proprio finché ci sforziamo di controllare tutto, perché ci sono tante cose da fare e non possiamo permetterci il lusso di essere, semplicemente stanchi, depressi, svogliati, capricciosi, noiosi, persino sbagliati e dementi, ecco sì, questo dementi?» [1]
“Idda” è un romanzo sull’identità, sulla memoria, sulla potenza profonda delle relazioni attraverso due figure femminili Annie e Alessandra che rappresentano chi siamo quando non ricordiamo più e chi siamo quando non ci prendiamo cura del passato. Fulcro del romanzo è arrivare al punto della consapevolezza e comprensione: siamo così ora perché c’è stato qualcosa nel passato. “Idda” è un romanzo forte, di impatto emotivo, che inchioda il lettore a quelle domande che cerchiamo di evitare forse per paura: chi siamo? Cosa resta di noi quando pezzi d’identità ci vengono strappati via? Cosa ci salva e si salva?
Il punto di partenza di questo romanzo era stato il tentativo di rispondere a una domanda che riguarda il rapporto tra identità e memoria partendo da qualcosa che mi aveva particolarmente colpito alcuni anni fa. In dipartimento avevo un collega, anche lui filosofo, la cui moglie aveva avuto l’Alzheimer precoce, e a cui avevo chiesto: «Ma quindi tua moglie non ti riconosce più?». E lui mi aveva risposto: «Guarda Michela il problema non è tanto se lei mi riconosco ma se io continuo a riconoscere lei ora che lei non è più la stessa persona di prima. Perché di fatto non è più quella persona che incontrai, di cui mi sono innamorato, che ho sposato, con la quale abbiamo condiviso gioie e dolori per un certo numero di anni». Io a quel punto ho cominciato a riflettere sul fatto che la questione identitaria non è tanto un “chi sono” statico anche se già nel “chi sono” in realtà si cerca di individuare il rapporto che esiste tra passato, presente e futuro. Ma il vero nodo della questione è quello che consiste nel chiedere se c’è qualcosa che rimane e che resta quando dall’esterno apparentemente, o anche realmente a volte, tutto ciò che ci caratterizza sembra venuto meno. È il caso di Annie, uno dei due personaggi del mio romanzo, che si ammala di demenza senile e comincia a perdere pezzi. Tutto il racconto che farà Annie in prima persona, cercando di raccontare il suo presente ma anche il suo passato, la porterà anche a rivalutare il proprio passato sarà proprio cercare sempre di rispondere alla stessa domanda: chi è oggi Annie? È sempre la stessa persona di prima? È la mamma di Pierre, anche se non riconosce più Pierre? Quindi a partire da qui ho cercato di costruire questa storia proprio per mostrare come nonostante pezzi interi della nostra esistenza scivolino via, nonostante talvolta la memoria scompaia, ebbene resta sempre qualcosa che fa sì che siamo le stesse persone di prima. Da un lato a livello di dignità e di valore noi abbiamo sempre lo stesso valore intrinseco e sempre la stessa dignità indipendentemente dal fatto che si perdano pezzi, che si sia caratterizzati dal meno piuttosto che dal più. Dall’altro lato c’è comunque qualcosa che resta a livello di affettività e a livello di amore. Le persone che hanno forme di Alzheimer o demenza senile, nonostante non si ricordino più tante cose, talvolta nemmeno più il proprio nome, continuano a mantenere legami di familiarità con le persone amate come se qualcosa facesse sì che nonostante tutto pur non riconoscendo si continuasse ad amare le persone care.
«Quello che invece non riesco proprio a concepire è come sia possibile passare dall’amore all’odio, perché papà, all’inizio, mamma l’amava. Amava tanto anche me. Ci sono cose che, sebbene l’amore che ci lega a una persona sia più profondo di un oceano, non possono essere né dette né spiegate. Nemmeno la persona che amiamo può ripagarci dei torti dell’esistenza. Lo sbaglio peggiore che si può commettere è attribuirle il potere di riparare la nostra vita. Ma ci sono anche cose che dovrebbero sempre essere dette, pure quando mancano le parole e si è certi di non essere capiti. Altrimenti pian piano ci si allontana, si spalanca la voragine dell’incomprensione, e persino l’amore più grande viene consumato dall’indifferenza.» [2]
Seppur con le nostre imperfezioni, mancanze, fragilità, a un vuoto che ci portiamo dentro, la salvezza però “viene dal meno”, da questi aspetti della nostra esistenza. A volte essere razionali, controllare le cose, cercare di essere performanti è solo sovrastruttura. Ciò che ci rende gli esseri che noi siamo, i residui del sé, sono proprio legati all’affettività, all’amore e ai sentimenti. Nel romanzo “Idda” c’è sempre l’amore che salva, omnia vincit amor. Aveva pensato a un finale alternativo?
L’importanza del finale è come non sia scontato. L’ho imparato pian piano quando mi sono spostata dalla saggistica alla narrativa perché in un saggio si sa perfettamente dove si va a parare. L’ipotesi di partenza si sviluppa per dimostrare e spiegare qualcosa. Con il romanzo, pur avendo un’idea chiara del punto di partenza, il senso del perché, del tema, dei personaggi, dell’inizio della storia, è la seconda volta (questo è il mio secondo romanzo) che mi sono scoperta sorpresa dal finale. A un certo punto i miei personaggi e la storia dei miei personaggi mi hanno suggerito se non addirittura imposto. Allora c’era naturalmente la voglia di cercare e di trovare una risposta alla domanda chi siamo, c’era la volontà di lasciare un messaggio rispetto al meno, quando a un certo punto la dottoressa Brun parlando con Annie e Pierre cerca di spiegare che come ognuno di noi abbia il diritto al decadimento, cioè ognuno di noi abbia il diritto da un momento all’altro di lasciarsi andare, di smetterla di controllare sempre tutto, di smetterla di cercare di essere sempre all’altezza delle aspettative, smetterla di cercare di essere sempre efficienti, efficaci, e quindi tutto il contrario rispetto al messaggio che ci dà la contemporaneità, che ci chiede sempre impegno, controllo. Quindi ognuno di noi ha diritto anche di essere meno: questo è un messaggio che io volevo dare fin dall’inizio però quello che mi ha sorpresa e che è emerso pian piano è stata la scoperta dell’importanza dell’affettività e dell’amore. Verrà alla fine, dopo questo lungo processo, quando Alessandra si sentirà nuovamente figlia agli occhi di Annie, lei che la madre l’aveva persa da ragazzina, lei che si era trasferita in Francia per chiudere con il proprio passato, quando nello sguardo di Annie si sentirà riconosciuta come figlia e amata, pian piano lì ho capito che quello che veramente resta di fatto di ognuno di noi è proprio questo amore e questa affettività. Sarà proprio alla fine che la dottoressa Brun tirerà le somme dicendo che quando parla con i pazienti con malattie neurodegenerative e chiede loro di scrivere o dire una frase, praticamente tutti dicono o scrivono “ti amo”, come se l’amore sopravvivesse anche all’oblio. Una cosa che mi ha colpito, rasserenato e confermato che doveva finire così il romanzo è quando ho ricevuto una lettera di una lettrice che mi scriveva che testimoniava che è proprio così, sua madre aveva dimenticato tutto e pur non riconoscendomi ha continuato ad amarla. È stata la conferma che questa chiusa è quella che doveva essere.
«L’amore resta, pure quando l’oblio ce la mette tutta per cancellarlo, l’amore non sparisce mai. E questo è più che sufficiente per dare coerenza a ciò che, di coerente, non sembra avere molto. Tanto, nella vita, i conti non tornano mai: si balbetta e si va avanti a tentoni, talvolta si frana e non ci si rialza, talvolta si ha la fortuna di poter ricominciare daccapo.» [3]
La scrittura di “Idda” non deve essere stata facile. Affrontare il tema della perdita della memoria e confrontarlo con una parte importante della sua vita privata. Infatti il libro è dedicato alla mamma di suo marito malata di Alzheimer, Renée. Non è facile parlare di un aspetto della propria vita personale, dell’alienazione esistenziale che porta con sé una malattia neurodegenerativa. È una ricerca della memoria disgregata, tra i perduti e nel terrore dei presenti, dei parenti, che dalla persona amata. Cosa è stato per lei questa ricerca in un mondo che non ha più confini temporali? Lei si è messa anche nelle vesti di Alessandra (con cui hai degli aspetti in comune, brillante carriera accademica – anche se lei è biologa -, Parigi,…): che cosa rimane di noi quando perdiamo la memoria? E cosa è stata per lei questa ricerca così profonda?
La scrittura di questo romanzo è stata particolarmente laboriosa ma per vari motivi. Intanto perché c’era un lato a tratti autobiografico. Anzi per certi aspetti la scrittura autobiografica, che avevo già sperimentato in “Io volevo essere una farfalla” con la mia storia, era stata coinvolgente emotivamente. Raccontavo però di me, alcune cose le potevo dire senza tradire la verità o le sfumature. Quando si è trattato di scrivere la storia di Annie, da un lato avevo effettivamente l’esperienza con la madre di mio marito, dall’altro mi sono informata per ricostruire la storia di una donna nata nel 1927, diventata nel 1945 segretaria dattilografa. Questo lato della ricerca e della scrittura è stato bello e a tratti anche divertente perché si trattava di ricostruire non solo la memoria individuale di questo personaggio ma anche la memoria collettiva della Francia degli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta. La parte difficile è stata la parte che riguardava il presente di Annie e quando dico il presente di Annie vuol dire la sua quotidianità nella perdita, il rapporto con il figlio Pierre che si deve raccapezzare pian piano in un mondo che di fatto non conosce. Perché quello che ha conosciuto fino a quel momento è stato un rapporto madre e figlio in cui il figlio poteva appoggiarsi sulla madre perché è la madre a prendersi cura di lui; confrontato con la demenza senile della mamma, Pierre è costretto a fare i conti con un momento difficile per tutti noi di figli in cui i rapporti si invertono, non sono più i genitori che si occupano di noi ma siamo che dobbiamo cominciare ad occuparci di loro. Quindi si trattava da un lato di essere giusta nel raccontare quello che gli specialisti chiamano il lutto bianco, cioè vivere il fatto che i genitori sono ancora vivi ma di fatto non sono più come prima. C’è una perdita ma non è una perdita definitiva. Dall’altro lato rendere giustizia alla realtà e al presente di Annie, di queste persone che ho frequentato e che ho imparato pian piano a conoscere e che mi hanno anche dato tanto. Io con Renée pensavo di dover aiutare lei quando ha cominciato a perdere pezzi, invece pian piano ho scoperto che con i suoi sguardi, i suoi gesti e con la sua presenza anche io avevo accesso a un pezzo di me che forse avevo trascurato fino a quel momento. Si trattava di restituire questa complessità delle relazioni nel momento in cui si pensa che le relazioni non esistano più perché in realtà esistono, ma vanno raccontate e per raccontarle bisogna cercare le parole giuste, quelle e solo quelle. C’è stato un lavoro che è durato parecchi mesi.
«Ci sono i non detti che avvelenano la vita. Può darsi sia colpa della memoria. Ma forse la memoria cerca solo di rettificare le cose, persino quando è tardi, e nulla riesce più a rendere giustizia alle vittime dell’esistenza. La memoria appare e scompare, ha detto la dottoressa Brun a proposito di Annie. Ma se l’oblio copre tutto, penso, forse è causa di qualcosa che è successo, che si è rotto, qualcosa che si è taciuto quando invece si sarebbe dovuto urlare, e allora pure i ricordi più belli finiscono con l’essere sepolti.» [4]
Il suo primo approccio alla narrativa è stato “L’amore che mi resta” (2017) sul tema del rapporto madre-figlia. Commovente, io lo lessi in pochissimi giorni. Leggendo i pensieri, i rapidi flash di Daria che pensava che l’amore potesse riparare ogni cosa, e che cade a pezzi dopo il suicidio della figlia Giada, ho rivisto molto del rapporto tra me e mia madre. È il dolore assoluto che le rivela che siamo nudi, vulnerabili. Eppure, quando smettiamo di chiedergli salvezza, l’amore ci salva. Scavando nella verità delle relazioni umane, parla di tutti noi. Del nostro desiderio di essere accolti e capiti, della paura di essere abbandonati, del nostro ostinato bisogno di amore, perché «senza amore si è morti, prima ancora di morire». In entrambi i tuoi romanzi ci racconti di donne Daria-Giada e Annie-Alessandra che intrecciano le loro vite. Sono donne che affrontano difficoltà insormontabili ma che poi si ritrovano, si riscoprono. Lei spinge il lettore ad indagare sulla sua quotidianità e sulla sua intimità, nel proprio senso di vita. È un bel compito!
Se riesco a farlo posso dire che questo lavoro di scrittura che sto portando avanti ha un senso perché io talvolta me lo chiedo: ma perché? Perché continuare? C’è un motivo? C’è un senso? Mi ricordo quando ero ragazzina: quando leggevo quello che a me piaceva nella lettura era la capacità di trovare in alcuni romanzi di spingermi e costringermi a fare i conti con me stessa e a cominciare un viaggio che mi permettesse identificandomi ad alcuni personaggi in questo viaggio alla scoperta anche delle mie contraddizioni, emotività e limiti. Dopo di che se ci sto riuscendo sia con “L’amore che mi resta” che con “Idda” per me è la cosa più bella che io possa sentirmi dire, se posso permettermi di rispondere in questo modo.
Che cosa ci riserva in futuro? Un ritorno alla saggistica? O porterà avanti il discorso di scrittura romanzesca con cui davvero riesce a rendere visibile le nostre zone d’ombra umane.
A me piacerebbe continuare a scrivere intanto. Sono forse ancora dentro a “Idda” che per ora proiettarmi in una scrittura futura non riesco a farlo. Mi piacerebbe continuare ma al tempo stesso so che, siccome ogni qualvolta che ho iniziato a scrivere ero sempre mossa e spinta da una forte urgenza, so che finché non ci sarà questa urgenza io non potrò scrivere altro. Dopo di che io non penso che sia per sempre abbandonata la scrittura saggistica perché comunque è uno strumento che serve, serve per spiegare, serve per argomentare. Io penso che al giorno d’oggi abbiamo anche bisogno di trasmettere ai più giovani gli strumenti di riflessione per poter sviluppare uno spirito critico. Io mi rendo conto anche insegnando ai miei studenti del primo e secondo anno, li vedo che alle volte fanno difficoltà, è come se la capacità logico argomentativa andasse stimolata. Magari un giorno ci sarà anche una struttura saggistica. Dopo di che quello che a me piace della scrittura letteraria è la speranza di trovare un tema che si imponga a me. La scrittura narrativa anziché spiegare si mostra, invece di argomentare si racconta. Quando si mostra e si racconta talvolta si riesce ad andare il più lontano rispetto a quando non si spiega e si argomenta almeno per quanto riguarda la questione dell’esistenza umana e della vulnerabilità della condizione umana. Di fatto posso spiegare e argomentare quando ho a che fare con un tema per esempio politico o anche con un tema morale, ma quando racconto il dolore e la sofferenza, le fratture, ho bisogno di mostrare più che argomentare. In realtà quando si argomentano e si spiegano cose che sono sempre immerse nel mistero dell’esistenza, si rischia di scivolare in una scrittura forse superficiale che è veramente l’unica cosa che spero di non fare mai, proprio perché la scrittura per me è sacra. C’è una funzione di sacralità nella scrittura, la ricerca delle parole, le parole evocative, mostrare ciò che succede, aprire delle porte, è sempre ciò che mi ha spinto poi ad andare avanti finora ed è sempre ciò in nome di ciò che ho cercato di darmi gli strumenti per portare avanti questo lavoro di esplorazione della condizione umana e della sua vulnerabilità.
Note
[1] Michela Marzano, “Idda”, Einaudi, 2019, pag. 126
[2] Ibidem, pagg. 218-219
[3] Ibidem, pagg. 231-232
[4] Ibidem, pag. 212