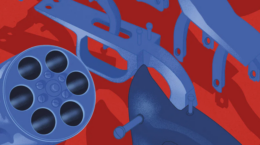Il 22 dicembre 1970, al Supercinema di Roma, Lo chiamavano Trinità viene proiettato in anteprima.
Costato 400 milioni di lire, il film arriverà a incassare circa 7 miliardi al botteghino italiano, secondo solo a Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Gli spettatori, tra i quali mio padre che raccontava sempre di essere stato tenuto su a braccia per non cadere dal seggiolino del cinema, ne decretano il successo a suon di risate fragorose.
Tutti tranne uno. Sergio Leone non ci trova nulla da ridere. Perché capisce subito che quel film mette la parola fine al filone d’oro, comunemente catalogato come western all’italiana, da lui scoperto solo sei anni prima.
Una paternità da cui, va sottolineato, Leone ha sempre preso le distanze, con quella spocchia pari in grandezza solo al suo genio: troppa distanza tra i capolavori da lui diretti, che avevano l’ambizione di riscrivere le regole di un genere profondamente radicato alla cultura americana, e il resto dei cosiddetti spaghetti western. Certo, il filone ha portato i buoni film dei vari Corbucci, Tessari, Sollima e Castellari, addirittura opere sperimentali e visionarie (due per tutte: Se sei vivo spara di Giulio Questi e Matalo! di Cesare Canevari, uscito due mesi prima di Trinità); ma a fronte di centinaia di titoli di serie Z girati nelle campagne laziali e finanziati da produttori trafficoni con i soldi di macellai romani smaniosi di investire nel cinema (per saperne di più c’è il monumentale Dizionario del western all’italiana di Marco Giusti, Mondadori).
Leone è comunque un buon padre che segue con affetto il figlio debosciato e illegittimo e, nonostante la consapevolezza del fatto che il genere stia tirando le cuoia – in un’intervista dichiara che “Nel momento in cui un titolo come Se incontri Sartana digli che è un uomo morto viene storpiato dal pubblico stesso e diventa Se incontri Sartana digli che è uno stronzo, significa che l’autore è stato smascherato e che il genere ha perso di credibilità” – il successo di Trinità non gli va proprio giù. E lo fa rosicare a tal punto da sostenere che Lo chiamavano Trinità sia un comico involontario, un western serio di cui l’autore ha perso il controllo. Voce ovviamente smentita dal regista del film, che rivendica l’intenzione di smitizzare un genere arrivato a un’esasperazione voyeuristica della violenza, ma rinforzata da chi lo ricorda furibondo e disorientato dalle risate che il 22 dicembre 1970 escono dalla sala del Supercinema di Roma.
La verità non la sapremo mai, data la schizofrenia di testimonianze che vanno da racconti precisi di aneddoti a tatticissime amnesie, e con tutta probabilità sta nel mezzo.
Ma andiamo con ordine.

Enzo Barboni è un direttore della fotografia. Operatore di macchina per i documentari bellici dell’Istituto Luce, è diventato, col tempo e col mestiere, un onesto artigiano del cinema, a cui ha regalato quel piccolo colpo di genio che è la fotografia sporca e sottoesposta del Django di Sergio Corbucci.
Da qualche tempo gira per Roma con sottobraccio la sceneggiatura di un film che vuole dirigere e che tutti i produttori rifiutano per la sua inconsistenza. È un western in cui “si parla troppo e si spara poco”, una storiella banale con poche idee che il produttore Italo Zingarelli, in crisi con la sua West Film, decide infine di finanziare quasi per amicizia. E lo fa portando a bordo due attori che ha sotto contratto, reduci da un’ottima trilogia western – diretta da Giuseppe Colizzi – e ormai noti al pubblico con gli pseudonimi di Bud Spencer e Terence Hill.
Il film viene girato nella campagna laziale del Parco dei Monti Simbruini, in un regime di totale libertà creativa che porta a tutte quelle idee visive e narrative che in sceneggiatura non c’erano. Ed è probabile che in questa sede Barboni prenda effettivamente coscienza del potenziale che ha tra le mani, spingendo all’esasperazione comica i tópoi del genere. La violenza brutale ha stancato? Ecco servite lunghe scazzottate coreografate come balletti. Le battute secche e lapidarie hanno fatto il loro tempo? Avanti con dialoghi tipo: “È il cielo che vi manda!”, “No, passavamo di qui per caso”. Sergio Leone fa l’Autore sostenendo che il cinema western è la sublimazione dei nostri giochi fanciulleschi? Allora il fratello di Trinità, infantile e rosicone come Leone stesso, si chiamerà Bambino. I pistoleri dalle facce funeree e agghindati come beccamorti non sono più credibili? Verranno presi a padellate e lasciati in mutande.

Se il personaggio medio del western italiano mangia con lentezza, spara veloce con sguardo di ghiaccio e indossa vestiti frusti – in contrapposizione alle frange in pelle e ai costumi lindi e colorati degli eroi americani – Trinità, sporco e sudato anche dopo essere uscito dalla vasca da bagno, va in scena con una maglia della salute bucata e una salopette di cui a malapena rimane la parte superiore, ammazza due cacciatori di taglie sparando dietro la schiena senza guardare e mangia quintali di fagioli ruttando fragorosamente.
La rivoluzione, involontaria o meno, è servita. E arriva già dai titoli di testa, con un cavallo che trascina la slitta su cui dorme il suo cavaliere. Mi piace pensare che sia una citazione di Django, che entrava in scena a piedi trascinando una bara.
Una rivoluzione che Barboni fa con uno pseudonimo, aggiungendo alle sue iniziali il cognome tedesco della madre: scritto e diretto da E.B. Clucher.
Il resto è storia.
Ma perché dopo mezzo secolo Trinità è ancora in sella (o, meglio, in slitta)? Perché le generazioni si succedono eppure è ancora impossibile cambiare canale quando viene passato in televisione?
In termini cinematografici è un film perfetto. Un prodotto di puro intrattenimento, certo, ma girato bene, ritmato, con dialoghi brillanti e una cura notevole per tutti i personaggi, figuranti compresi. Chi non ricorda il messicano diventato assassino per difendere l’onore della sua esposa che stava al fiume a lavare o lo scagnozzo Emiliano, che non tradisce fino a quando non ha la canna di una pistola infilata nel naso? Momenti iconici, senza dubbio, entrati nell’immaginario collettivo come la pasta e ceci de I soliti ignoti o Anita Ekberg a mollo nella fontana di Trevi.
Ma Trinità è qualcosa di più.
È quasi una questione di famiglia che si tramanda di generazione in generazione, che tu sia maschio o femmina. Mio padre, grande appassionato di western tanto da portare avanti tutt’ora la collezione completa di Tex, mi fece conoscere Trinità ancor prima dei film di Leone o di John Ford. E corredò il tutto cucinandomi una zuppa di fagioli e pancetta in salsa rossa permettendomi, ma solo perché lo faceva Terence Hill, di mangiarli impugnando il cucchiaio come una cazzuola. Se ne pentì più tardi quando, per lungo tempo, ad ogni portata chiedevo quanti piatti ne avrebbero mangiati Bud Spencer e Terence Hill, ma cosa non si fa per i figli.
Trinità diventa, dunque, libertà, anarchia, elogio della pigrizia, dello sbadiglio in punta di labbra, del talento sprecato. È un diesel che si accende solo per una buona causa, come quel fischio stanco e indolente che accompagna i titoli di testa, diventa colonna sonora trionfante e che da 12 anni è la suoneria del mio cellulare. Nonostante, nel frattempo, ne abbia cambiati cinque.
Trinità è il gioco del bambino che si allena a far roteare la pistola nel fodero, è l’adolescente che si mette in mostra ammaliato dagli occhi di “due bionde cerbiatte”, è lo studente che dorme sul treno, è la serata senza pensieri sul divano, quando chiudi il mondo fuori dalla porta e rutti le scorie della giornata dopo aver scolato una birra. È il talento, tutto italiano, di alleggerire e dissacrare con un gesto, come mettere una mucca sul tetto di una locanda nella prima scena di un film western.
Trinità siamo noi.
Sergio Leone continuò a odiarlo, tirò in ballo Freud per giustificarne il successo – gli spettatori stavano uccidendo la madre – ma finì lui stesso in una sorta di autoanalisi autoriale che lo condusse, 3 anni più tardi, a quel gioiellino che è Il mio nome è Nessuno.
Ma questa è un’altra (bella) storia.
Davide Cerreja Fus