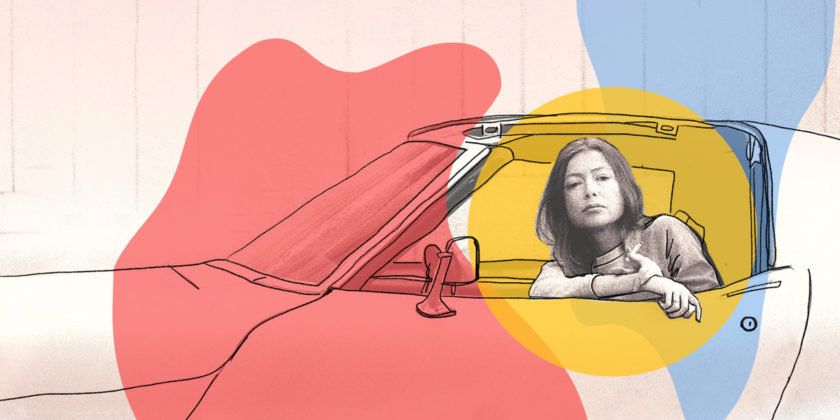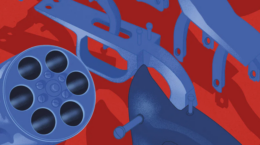«Ma tu mi ami?» chiese Alice.
«No, non ti amo.» rispose il Bianconiglio.
Alice corrugò la fronte e iniziò a sfregarsi nervosamente le mani, come faceva sempre quando si sentiva ferita.
«Ecco, vedi? – disse il Bianconiglio – Ora ti starai chiedendo quale sia la tua colpa, perché non riesci a volerti almeno un po’ di bene, cosa ti renda così imperfetta, frammentata. Proprio per questo non posso amarti. Perché ci saranno dei giorni nei quali sarò stanco, adirato, con la testa tra le nuvole e ti ferirò. Ogni giorno accade di calpestare i sentimenti per noia, sbadataggine, incomprensione. Ma se non ti ami almeno un po’, se non crei una corazza di pura gioia intorno al tuo cuore, i miei deboli dardi si faranno letali e ti distruggeranno.
La prima volta che ti ho incontrata ho fatto un patto con me stesso: mi sarei impedito di amarti fino a che non avessi imparato tu per prima a sentirti preziosa per te stessa. Perciò, Alice no, non ti amo. Non posso farlo.»
 Nata a Sacramento in California nel 1934, Joan Didion resta una straordinaria e incredibile giornalista, saggista e scrittrice. Nel 2017 è uscito il documentario diretto dal nipote Griffin Dunne Joan Didion: The Center Will Not Hold su Netflix sulla sua straordinaria carriera e sulle sue battaglie personali. Nel 2018 invece ancora più interessante è il libro Da dove vengo. Un’autobiografia sugli aneddoti di famiglia a partire dalla sua “bis-bis-bis-bis-bisnonna Elizabeth Scott” nata nel 1766 fino alla casa sulla costa dell’Oregon dove è cresciuta, piena degli oggetti curiosi come fili di conchiglie e semi di Tahiti, uova di emù intagliate, vasi Satsuma, spade del Pacifico del Sud, una miniatura del Taj Mahal in alabastro e i cesti donati a sua madre dagli indiani locali.
Nata a Sacramento in California nel 1934, Joan Didion resta una straordinaria e incredibile giornalista, saggista e scrittrice. Nel 2017 è uscito il documentario diretto dal nipote Griffin Dunne Joan Didion: The Center Will Not Hold su Netflix sulla sua straordinaria carriera e sulle sue battaglie personali. Nel 2018 invece ancora più interessante è il libro Da dove vengo. Un’autobiografia sugli aneddoti di famiglia a partire dalla sua “bis-bis-bis-bis-bisnonna Elizabeth Scott” nata nel 1766 fino alla casa sulla costa dell’Oregon dove è cresciuta, piena degli oggetti curiosi come fili di conchiglie e semi di Tahiti, uova di emù intagliate, vasi Satsuma, spade del Pacifico del Sud, una miniatura del Taj Mahal in alabastro e i cesti donati a sua madre dagli indiani locali.
La scrittura per Didion è un artificio, una mediazione e quindi non può essere considerata un modo per interpretare la realtà. Questo perché è perfettamente conscia dell’impossibilità di districare quel nodo che è la realtà che la circonda, preferendo spostare sempre più in là la sua analisi: dall’America del dopoguerra, i non-luoghi della società di massa, all’analisi di sé stessa come scandaglio di dolore e riflessioni sul rapporto tra morte, dolore e scrittura. Ovviamente si dovrebbe partire dal fondamentale The Year of Magical Thinking, che racconta dell’anno funesto in cui l’autrice perde prima il marito e poi si prende cura della figlia in coma: un anno che le insegna ad accettare la vita, a cambiare le proprie coordinate di riferimento, a ragionare su infelicità e felicità, a distanziare e un tempo per accettare il dolore. Questo “anno del pensiero magico” di grande rivoluzione personale è raccontato non solo attraverso l’autobiografia del lutto, ma utilizzando inserti da studi psicologici e medici che le servono quasi da auto-analisi. Alla morte della figlia, accaduta dopo la morte del marito, Didion dedicherà invece un altro libro reportage, Blue Nights. Il titolo richiama quella particolare tonalità del crepuscolo che in certi periodi dell’anno prima del solstizio d’estate di un blu intenso precede l’oscurità. Scrive in una nota prefatoria:
«Questo libro si intitola “Notti azzurre” perché all’epoca in cui lo iniziai i miei pensieri erano sempre più concentrati sulla malattia, sulla fine della promessa, l’affievolirsi dei giorni, l’inevitabilità della dissolvenza, la morte del fulgore. Le notti azzurre sono l’opposto della morte del fulgore, ma ne sono anche l’annuncio. Noi ci raccontiamo delle storie per vivere.»
Caratterizzata da una stravaganza vitale, Didion ha deciso di trascorrere la sua vita rispecchiandosi in sé stessa esaminando anche la moralità in un breve saggio del 1965 intitolato Sulla moralità in Slouching Towards Bethlehem, la raccolta di saggi del 1968 su come tenere un quaderno e la sua riflessione sull’autostima. La scrittrice è stata la testimone diretta di uno dei momenti più cruciali della storia degli Stati Uniti: gli anni Sessanta. Con un occhio alla tendenza di confondere con la moralità ciò che è davvero una mostruosa perversione dell’ego, Didion scrive:
«“I followed my own conscience.” “I did what I thought was right.” How many madmen have said it and meant it? How many murderers? Klaus Fuchs said it, and the men who committed the Mountain Meadows Massacre said it, and Alfred Rosenberg said it. And, as we are rotely and rather presumptuously reminded by those who would say it now, Jesus said it. Maybe we have all said it, and maybe we have been wrong. Except on that most primitive level — our loyalties to those we love — what could be more arrogant than to claim the primacy of personal conscience?»
Mezzo secolo dopo, il punto di vista di Didion sembra ancora più attuale nella nostra cultura, in cui la bolla filtrante delle nostre lealtà ha reso ancora più primitiva la nostra realtà e dove combattiamo il nostro costante terrore di venire slegati dal nostro certezze soccombendo all’auto-giustizia sfrenata sotto il pretesto della moralità. Didion considera come questa tendenza ci abbia reso meno morali piuttosto che maggiormente:
«You see I want to be quite obstinate about insisting that we have no way of knowing — beyond that fundamental loyalty to the social code — what is “right” and what is “wrong,” what is “good” and what “evil.” I dwell so upon this because the most disturbing aspect of “morality” seems to me to be the frequency with which the word now appears; in the press, on television, in the most perfunctory kinds of conversation. Questions of straightforward power (or survival) politics, questions of quite indifferent public policy, questions of almost anything: they are all assigned these factitious moral burdens. There is something facile going on, some self-indulgence at work.»
 Naturalmente vorremmo tutti credere in qualcosa, come placare le nostre colpe private in cause pubbliche, come perdere la noia di noi stessi, come trasformare la bandiera bianca della sconfitta nel coraggioso stendardo bianco della battaglia. Tutto ciò va bene solo fintanto che non ci illudiamo su ciò che stiamo facendo e sul perché, solo fino a quando riconosciamo che la fine può o meno essere opportuna, può o meno essere una buona idea, ma in ogni caso non ha nulla a che fare con la moralità. Perché quando iniziamo a ingannarci nel pensare non che vogliamo qualcosa o che abbiamo bisogno di qualcosa, non che sia una necessità pragmatica per noi averlo, ma che sia un imperativo morale il volere o l’aver bisogno di qualcosa.
Naturalmente vorremmo tutti credere in qualcosa, come placare le nostre colpe private in cause pubbliche, come perdere la noia di noi stessi, come trasformare la bandiera bianca della sconfitta nel coraggioso stendardo bianco della battaglia. Tutto ciò va bene solo fintanto che non ci illudiamo su ciò che stiamo facendo e sul perché, solo fino a quando riconosciamo che la fine può o meno essere opportuna, può o meno essere una buona idea, ma in ogni caso non ha nulla a che fare con la moralità. Perché quando iniziamo a ingannarci nel pensare non che vogliamo qualcosa o che abbiamo bisogno di qualcosa, non che sia una necessità pragmatica per noi averlo, ma che sia un imperativo morale il volere o l’aver bisogno di qualcosa.
 Slouching Towards Bethlehem rimane una lettura indispensabile. Include anche una questione dalla sfera privata di mancanza di amore per se stessi e di indagarsi su tutto ciò. La cosa più devastante è che l’autostima non ha nulla a che fare con l’approvazione degli altri. Nonostante tutto, il carattere – la volontà di accettare la responsabilità della propria vita – è il luogo in cui nasce l’amore per se stessi. L’amore di sé è qualcosa che i nostri nonni sapevano perfettamente, che lo avessero o no. Già da giovani in loro era stata instillata una certa disciplina, la consapevolezza che si vive facendo cose che non si ha un desiderio speciale di fare, lasciando da parte paure e dubbi e soppesando conforti immediati in relazione ad altri maggiori conforti che possono anche essere intangibili. Avere quel senso del proprio valore intrinseco che costituisce il rispetto di sé significava avere potenzialmente tutto.
Slouching Towards Bethlehem rimane una lettura indispensabile. Include anche una questione dalla sfera privata di mancanza di amore per se stessi e di indagarsi su tutto ciò. La cosa più devastante è che l’autostima non ha nulla a che fare con l’approvazione degli altri. Nonostante tutto, il carattere – la volontà di accettare la responsabilità della propria vita – è il luogo in cui nasce l’amore per se stessi. L’amore di sé è qualcosa che i nostri nonni sapevano perfettamente, che lo avessero o no. Già da giovani in loro era stata instillata una certa disciplina, la consapevolezza che si vive facendo cose che non si ha un desiderio speciale di fare, lasciando da parte paure e dubbi e soppesando conforti immediati in relazione ad altri maggiori conforti che possono anche essere intangibili. Avere quel senso del proprio valore intrinseco che costituisce il rispetto di sé significava avere potenzialmente tutto.