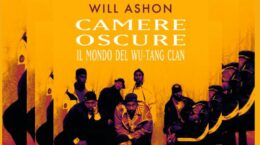«Dal caschetto di capelli biondi spunta una sottile antenna che gli arriva sulle fronte, come se fosse un terzo occhio. – Anni fa la paragonavano ai Google Glass. Poi i ragazzini mi chiedevano se fosse una versione particolare di selfie stick. La scorsa estate tutti mi cercavano di catturare: pensavano fossi un Pokémon – . Lui si chiama Neil Harbisson, è originario della Catalogna ed è il primo cyborg ufficialmente riconosciuto».
Corriere della Sera, 22 luglio 2017
Cambiare se stessi piuttosto che cambiare il mondo. È questa la “rivoluzione” del nostro millennio: non più la sovversione o l’abbattimento di dinamiche socioeconomiche devianti, bensì un passivo adattamento alle stesse tramite le innovazioni tecnologiche. Un fenomeno definibile “graduale disumanizzazione dell’umano”, come proverò ad argomentare più avanti – che sembrerebbe aver avuto impatto anche sull’arte, in particolare sull’universo musicale: quanto e come il progresso ha trasformato la figura/funzione delle rockstar all’interno della nostra società?
Nella storia del rock esiste una band che più di tutte ha saputo rispondere a questo interrogativo. Protagonisti del panorama musicale britannico, i Radiohead si formano alla fine degli anni ’80 con il nome di On A Friday – giorno in cui il gruppo si riuniva per provare nell’aula di musica della Abingdon School di Oxford. Il nome “Radio Head”, utilizzato dal 1991 in poi, è ispirato all’omonimo brano dei Talking Heads, il cui ritornello canta: «Hey, radio head! This is the sound of a brand-new world», esprimendo la consapevolezza che il mondo a cui siamo abituati stia rapidamente cambiando.

Thom Yorke, Ed O’Brien, Philip Selway e i fratelli Greenwood nascono tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, crescendo in un’epoca di grandi epiloghi (alcuni esempi: la caduta del muro di Berlino; la fine della Guerra Fredda; il declino del movimento hippie e delle rivolte studentesche, ecc.); a questi eventi va a contrapporsi, in parallelo, l’ascesa del modello capitalista, della società industriale e della cultura massificata – quest’ultima, esplosa con la Pop art di Andy Wharol e Roy Lichtenstein. I mass media veicolano messaggi di consumismo incontrollato e “felicità a ogni costo”, che fanno da contraltare al disfattismo susseguente (in un primo momento) ai conflitti mondiali; l’industria culturale sforna modelli di successo e positività (attori, cantanti, star hollywoodiane, ecc.) a cui i giovani sono chiamati a omologarsi e coloro che, anni dopo, rifiuteranno questi modelli, oltre ai valori “prefabbricati” della propaganda capitalista, si guadagneranno l’appellativo mediatico di X Generation: una generazione tacciata di essere apatica, grigia, senza principi e identità (da qui, l’utilizzo lettera “X”).
Le nuove stelle del rock (1990) appartengono proprio alla X Generation. Non a caso, il divismo mediatico carico d’ingenuo ottimismo, che imperversava su grande e piccolo schermo negli anni ’60, era stato indebolito da episodi come il suicidio di Marilyn Monroe: il declino della stella trionfante, l’autoeliminazione di un agognato quanto illusorio ideale di benessere; e così, negli anni ’90 una larga fetta di pubblico acclama artisti come i Radiohead, interpreti del nuovo sentire dei fan. Thom Yorke si fa portavoce della X Generation con il singolo Creep, inno dedicato agli “stramboidi”, emarginati da quella società posticcia e “vampiresca” (come canterà più tardi Billy Corgan in Bullet With Butterfly Wings) dalla quale Yorke non vuole farsi divorare; il brano ha un enorme successo, sebbene l’album Pablo Honey (1993) non si discosti troppo dal brit-pop di retroguardia allora in voga. La carriera dei Radiohead prosegue con The Bends (1995), disco che traduce in suono il senso di abulia e impotenza rispetto alle spinte di un fenomeno più tardi definito “realismo capitalista”. Tra i brani spicca (per immaginario, suono e tematiche) la ballata Fake Plastic Trees: favola dark i cui protagonisti vivono una vita di plastica in un universo di plastica, e definisco il loro amore (anch’esso “plastificato”) «the real thing».
Con Ok Computer (1997), pietra miliare in cui sono riconoscibili molte influenze diverse (tra le altre: Pink Floyd, Genesis, Miles Davis, Ennio Morricone e Dj Shadow), i Radiohead scrivono una sorta di “Manifesto cyborg” che evoca atmosfere fantascientifico-distopiche. La poetica dei Radiohead è ribellione a un futuro orwelliano che si è fatto presente grazie alla marcia inarrestabile del progresso; e allora, in risposta a un addomesticamento socioculturale che sembrerebbe irreversibile/ineluttabile, le strutture musicali si disarticolano, i tempi si dilatano, i generi si mescolano in una schizofrenia melodica che trova nella sovrana libertà dell’indefinito, del selvaggio, dell’irrisolto, la propria identità. Dopo l’enorme successo di Ok Computer, tuttavia, in molti si sono chiesti cosa fosse rimasto dei cari, vecchi “creep”: i Radiohead sembrano diventati parte di quel mostruoso apparato che, in un primo momento, avevano inteso criticare, perfino distruggere. E lo sanno bene.
Il brano How To Disappear Completely (and never be found again), traccia dell’album Kid A (2000), può considerarsi la confessione a denti stretti di una band che si sente annichilita, in qualche modo fagocitata, dal sistema capitalistico di massificazione dell’arte. «That there, that’s not me/I’m not here, this isn’t happening» canta Yorke, consapevole che il rock è solo un ingranaggio di quella grande macchina di controllo mediatico alla quale sembra impossibile sottrarsi, e che vede nella musica uno dei suoi prodotti più riusciti (come affermerà Mark Fisher riguardo al suicidio di Kurt Cobain e alla “MTV generation”). Il ritmo e il suono di Kid A sono ispirati ad artisti come Aphex Twin e Autechre: i Radiohead virano decisi verso l’elettronica, passando per il trip-hop dei Massive Attack e della scuola di Bristol. Brano emblematico, Everything In Its Right Place: una cupa implosione di tastiere mescolata alla voce di Yorke, che snatura in eco digitale fino a scomparire. Il pezzo sembrerebbe rappresentare la metaforica apertura degli occhi su di una realtà inquietante, nella quale «ogni cosa è al suo posto», quello in cui l’avevamo lasciata quando, guardando al futuro, speravamo di star facendo un brutto sogno: emerge, ancora una volta e con rinnovata potenza, l’orrore per i giorni che verranno, da cui bisogna fuggire prima che sia troppo tardi – ma il troppo tardi, ormai, è arrivato.

Kid A esce nel 2000, anno ponte tra i Millennial e la Generazione Z – i nati digitalizzati, immersi nel liquido amniotico del web, la cui identità si fonda non più sul rifiuto di un io “massificato” (come era stato per la X Generation), ma sull’esaltazione esasperata del quell’io tramite la Grande Ragnatela: si apre così la strada a una sorta di “ipertrofismo della dimensione individuale”, a discapito di quella collettiva. Da questo momento in poi, l’industria musicale proporrà ai Millennial e alla Generazione Z nuove rockstar: modelli standardizzati di autorealizzazione del singolo, possibile grazie ai mezzi offerti da Internet (Facebook–2004, YouTube–2005, Twitter–2006, Instagram-2010, ecc.). Mezzi che, peraltro, sembrerebbero rendere le stelle finalmente “terrene”: perché che cos’è, in fondo, un divo del web? Un’icona rappresentativa di un mero criterio di proporzionalità diretta tra popolarità sui social media, gradimento del pubblico, successo commerciale e, infine, riconoscimento artistico.
Se lo vogliamo, l’arte e il successo che ne deriva possono essere facili, immediati, indolori e accessibili – questo ci insegna la propaganda capitalista: sia a livello pratico/economico, perché l’utilizzo di mezzi come YouTube e Instagram permette (tra le altre cose) di abbattere i costi di produzione; sia a livello espressivo, perché, per quel che concerne le motivazioni sottese al gesto creativo, il fenomeno che prima ho definito “ipertrofismo della dimensione individuale” spinge gli artisti a ignorare la loro parte più intima e tormentata, preferendo messaggi semplici, epidermici, che non sottendano alcun “sacrificio di sangue” (concetto su cui mi soffermerò nei paragrafi successivi), oppure legati all’autocelebrazione, alla retorica del “mi sono fatto da solo, quindi puoi farcela anche tu”. Amnesiac (2001), registrato durante le stesse session di Kid A, pare quasi un’anticipazione delle conseguenze di questo cambiamento: il fenomeno della massificazione dell’arte la rende più accessibile, ma forse meno sofferta e per questo (pericolosamente) gratuita. Più nello specifico, ciò che di Amnesiac colpisce rispetto al gemello Kid A è la rinnovata presenza dell’elemento umano: la voce di Yorke non è distorta né filtrata, e le parole riacquistano l’importanza che in Kid A avevano perduto – degradate a contenitori di suono, versi di robot male oliati; sembra quasi che Yorke stia tentando di ripristinare quella dimensione vulnerabile, umana, fatta di carne e di sangue, che il progresso sta sottraendo alle rockstar.
Dopo una pausa dalle scene e l’album Hail to the Thief (2003), i Radiohead lanciano In Rainbows (2007), acquistabile in download tramite offerta della cifra ritenuta congrua dagli utenti (dunque, anche zero). Il disco pone un fondamentale quesito agli internauti: quanto vale la musica nell’era del digitale? Sei davvero disposto a pagare per qualcosa che puoi scaricare comodamente online? A livello concettuale, In Rainbows possiede la carica rivoluzionaria che Kid A aveva sul piano musicale: testimonia che, nel momento in cui la musica si spoglia del supporto fisico (cassetta, vinile e/o CD), dunque di quello che potremmo chiamare “corpo”, essa si espone alla svalutazione proprio a causa della sua volatilità/immediata disponibilità – caratteristiche, queste, che possono influenzare negativamente la percezione degli utenti. In Rainbows è considerato il lavoro più maturo della band, perfetto bilanciamento tra digitale e analogico; il successivo The King of Limbs (2011) predilige invece sonorità elettroniche, ispirate ad artisti quali Burial, Four Tet e Flying Lotus. I dischi hanno un elemento in comune: esprimono il malessere di generazioni condannate all’involuzione emotiva e all’isolamento, schiave della connessione Internet h24 e delle innovazioni tecnologiche (IPod, Spotify, ecc.) – innovazioni che, sebbene abbiano introdotto molti cambiamenti positivi, rischiano di condannare la musica alla gratuità.
Sembra questo il momentaneo epilogo di un percorso che, ridisegnando gli assetti della società, ha stravolto anche l’arte. Cosa ne è stato della fisicità degli artisti, della loro dimensione umana ed emotiva, del contatto tra artista e pubblico, del “sacrificio di sangue” che è presupposto necessario alla creazione di qualsiasi opera d’arte? Per dirla con le parole di Louis-Ferdinand Céline:
«Se non mettete la vostra pelle sul tavolo, non avete nulla. Uno deve pagare! Quello che è fatto senza pagare, non conta nulla, vale meno del nulla […]. E quello che è gratuito, puzza di gratuito».
Il tema della gratuità, tanto in termini di ritorno economico, quanto in termini di motivazione/spinta al gesto creativo, è più che mai attuale, come avevano intuito i Radiohead anche prima di In Rainbows: le rockstar, così come la loro arte, sembrerebbero condannate a dissolversi nella massa nebulosa del web, fagocitate dalla fame crescente di prodotti prêt-à-porter, facili da digerire, che non lascino traccia di sé nel fruitore convinto a saziarsene. Una gratuità bilaterale, si potrebbe dire: sia dal lato dell’artista – che in molti, troppi casi non mette più “la sua pelle sul tavolo”, ma si accontenta di “valere meno del nulla”; sia dal lato della fanbase, spesso orientata verso un consumo veloce, quasi istantaneo, possibilmente non remunerato ed esente da contatto col sangue metaforicamente versato dall’artista.
E quella stessa fanbase – più in generale: il grande pubblico – attraversa una mutazione psicofisica importante: ingloba la tecnologia nella propria quotidianità e nel proprio corpo, quasi che rinunciare al progresso, all’innovazione, significhi rinunciare alla possibilità stessa di dirsi umani. Emblematici, a tal proposito: (i) Neil Harbisson, il primo cyborg ufficialmente riconosciuto – che si è fatto impiantare un’antenna in testa per “ascoltare i colori”, e (ii) il microchip sottocutaneo brevettato da alcune aziende per far compiere ai dipendenti operazioni di modesta entità (i.e. timbrare il cartellino). Cambiare se stessi piuttosto che cambiare il mondo, dunque; e piegare il proprio corpo, di conseguenza anche il corpo dell’arte, alle derive del progresso.

E mentre le stelle del rock si eclissano dietro icone volatili, profili social e gara agli ascolti su YouTube e Spotify, i Radiohead propongono al mercato A Moon Shaped Pool (2016): un album con cui Yorke, all’opposto, sembrerebbe volersi avvicinare ai fan in modo più intimo, forse anche in ragione della separazione dalla compagna Rachel Owen (che morirà poco dopo l’uscita del disco). Si percepisce distinto il bisogno di Yorke di comunicare un dolore altro dall’inquietante dimensione fantascientifica alla P. K. Dick di Ok Computer o dal solipsismo dell’uomo-androide di Kid A: una sofferenza che ricorda l’umanità perduta (o meglio, momentaneamente archiviata) della nostra “epoca-cyborg”. La ballata True Love Waits è una versione moderna delle canzoni d’amore, e forse lo è l’intero A Moon Shaped Pool – l’estremo tentativo della musica, in controtendenza rispetto all’andamento generale, di recuperare una pelle, un corpo, un cuore che sia capace (e abbia il coraggio) di sanguinare: il giusto prezzo da pagare affinché l’arte possa affrancarsi, finalmente, da tutta questa, deprimente gratuità.