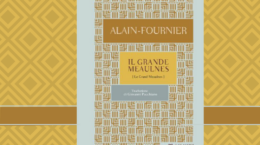di Silvia Cannarsa
Ho finito quello che avevo da fare. Consegnato tutti i compiti, ho fatto anche gli orali. Ho parlato con le persone giuste e frequentato le compagnie giuste. Mi hanno applaudita alla fine dell’esame, c’è chi mi ha amato, chi avrebbe voluto essere me per quell’istante, chi mi ha detestata dal primo giorno di scuola.
Adesso sono seduta su una sedia di legno in cortile, in mezzo alle famiglie degli altri diplomandi che urlano. È l’ultimo giorno degli orali di maturità, cerco di respirare e di mettere in ordine i pensieri per raccontarmi meglio quanto è stato emozionante e che non vorrei rifarlo mai più. Aspettano me per il brindisi, per alzare il bicchiere. Si aspettano che versi da bere a tutti, che faccia le mie solite scene da buffona e che inviti con noi i professori che per tutta la vita mi sono stati nemici, ora invece siamo dalla stessa parte della barricata. No? Vogliono il discorso, vogliono sentirmi dire che andrà tutto bene, che non aspettavamo nient’altro, che non ci siamo preparati per nient’altro. Tutti quegli anni dietro a quei banchi per poi andare nel mondo reale, affrontarlo e vincerlo con un coltello tra i denti e una benda sull’occhio. Noi lo conquisteremo questo cazzo di mondo, e allora alzate i calici, non torneremo più dietro a quei banchi a farci umiliare perché ne sappiamo meno degli altri. Ora sappiamo tutto quello che dobbiamo sapere, e se andrà male sarà solo perché non ci abbiamo creduto abbastanza. Il mondo è ai nostri piedi.
E allora perché non riesco a sorridere?
Mi tremano le guance tutte le volte che ci provo, una cappa si è abbattuta sulla mia fronte e sugli occhi, ho le palpebre così pesanti che non riesco a guardarmi intorno, gli altri dove sono? Sono l’unica che ha perso il controllo?
Riesco a sentire i capelli, uno a uno, sulla mia testa, li sento che sono inseriti nel loro bulbo, nel mio cuoio capelluto, si appoggiano pesantemente alle orecchie, si abbandonano sulle spalle, morti.
Voglio qualcosa da stringere, da abbracciare, voglio che qualcuno mi abbracci, ma non voglio che qualcuno mi abbracci, ho paura che se mi metto a piangere non mi fermeranno più, e gli argini stanno crollando, e la festa non è ancora iniziata, e la pioggia dentro di me continua a battere, e il fiume si ingrossa e dentro ci sono troppi detriti, è inarrestabile e si porta via tutto, alberi, arbusti, papere incolpevoli sedute su un sasso, e anche il mio cuore, dove è andato il mio cuore?
Sono ancora seduta sulla mia sedia in cortile. Il trucco non si è sciolto, i capelli sempre stati al loro posto, posso ancora respirare.
Vedo Giulio in lontananza, in mezzo a un sacco di persone. Mi saluta e mi fa cenno di raggiungerlo. Ha ancora la giacca sulle spalle, anche se ormai sfioriamo i trenta gradi. Bello Giulio, con i denti perfetti e le orecchie che sembrano patatine. Attraverso il cortile, scanso un gruppo di padri pieni di mazzi di fiori per le figlie, e supero le aiuole allungando il passo, il tacco affonda nel terriccio fresco. Guardo le scarpe coi tacchi che ho comprato in sconto a 14,90 €, per le grandi occasioni, si stanno sporcando, le guardo sprofondare in mezzo alle ortensie e poi Giulio mi prende per il braccio e mi fa uscire dall’aiuola. Ride con me, e mi dà una delle sue pacche sulle spalle. Gli piacevano gli AC/DC a Giulio, e anche il giorno della maturità, sotto la giacca elegante ha la maglia nera con il nome del gruppo scritto sopra, in rosso. Scuoto la testa e gli passo il braccio attorno alle spalle. Sto tornando in me. Mi faccio trascinare in mezzo agli altri. Sante mi bacia appena li raggiungo, Scilla mi prende per le spalle e mi scuote ridendo e mi urla: “Ripigliati, scema”, non posso biasimarla, sono ancora sconvolta. E io guardo Sante, i suoi occhiali spessi, e quegli occhi enormi, fuori misura, dietro gli occhiali, e penso che ci siamo amati un sacco, per avere diciott’anni. Quando penso a Sante, penso a noi due in biblioteca, a studiare in silenzio, lasciando che che i nostri avambracci si sfregassero di tanto in tanto, a guardarci sopra ai libri, a fumare sulle scale antincendio, avvolti nella stessa sciarpa, a farmi accendere le sigarette tenendogli stretta la mano con l’accendino tra le mie.
Scilla mi lega un braccialetto al polso mentre mi parla, dice così tante parole quando è agitata e non riesco ad ascoltarla. Mi dice che se n’è comprata uno uguale anche lei, mi dice tienilo sempre, anche sotto la doccia, mi dice, se quest’estate non ce l’hai quando vieni a trovarmi ti meno. Le stringo la mano e le do un bacio sulla guancia. Senza di lei quegli anni sarebbero stati ancora più duri. Lei c’era quando è morto mio padre ma avevo il test di verbi latini, c’era dopo il funerale, quando ci siamo chiuse in camera a ripetere e a bere grappa in minuscoli bicchieri di vetro. C’era anche quando ho detto a Sante che lo amavo, era proprio lì in prima fila, e se avesse avuto una trombetta l’avrebbe suonata. Splendida Scilla, so che ora fa la maestra, benedetta lei, non la sento da anni, da quando sono partita per il Sud America per trovare me stessa e non ho più scritto a nessuno. Poi alla fine me stessa non l’ho trovata, o almeno non quella che avrei voluto trovare, e sono tornata dal Sud America, ma ho continuato a non scrivere a nessuno. Chissà perché ci si comporta così a volte. Forse perché uno si vergogna così tanto di non esserci stato e di non essersi trovato che poi i sensi di colpa continuano ad ammassarsi e alla fine non fai niente, rimani raggelato, immobile.
Entro a scuola, in segreteria c’è il mio zaino, ne tiro fuori due bottiglie di vodka tonic, sono due bottiglie di plastica di acqua senza l’acqua. Ne passo una a Sante che mi ha seguita, fa una sorsata corposa, mi guarda e mi sorride.
Lo sa che andrà a studiare in Belgio? Lo sa già che mi lascerà un giorno di settembre in cui c’è un sole svergognato che illumina proprio noi che ci stiamo lasciando?
Mi circonda con un braccio e mi bacia in mezzo a tutti gli zaini degli studenti che si diplomeranno quel giorno, sono zaini pieni di bottigliette d’acqua di plastica come le mie, piene di gin, piene di vodka lemon, piene di coca e rum. Alzo la bottiglia al cielo, le bidelle mi sorridono, lo sanno anche loro che saremo ubriachi da lì a dieci minuti, ma ormai non siamo più un loro problema.
Torno in cortile, mi trascino dietro una sedia, mi preparo a fare quello che si aspettano da me. Quando raggiungo il centro tutti mi stanno già guardando, al mio passaggio alzano le bottiglie davanti ai loro genitori stupiti. I professori sono sul chi vive e si pettinano i baffi, la Sardo, di inglese, mi fa no con la testa. “Pericoli, si plachi”, significa quel no.
Salgo sulla sedia: “Compagni,” urlo, come se fossi in Russia, e quello fosse ottobre 1917, non un 2000 qualunque, in Italia, in un liceo classico del centro, “siamo liberi. Siamo finalmente liberi come gabbiani, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ora. Possiamo diventare medici, avvocati, ingegneri. Possiamo anche diventare degli accattoni, dobbiamo solo sceglierlo, amici miei”. Urlano, battono i piedi e fanno un sorso. Ne bevo uno anch’io per farmi coraggio. Non ho mai avuto problemi a parlare in pubblico, ma sento le gambe che tremano.
Giulio tiene la sedia sotto di me, un giorno finiremo a letto insieme e sarà per quello che Sante mi lascerà prima di partire per il Belgio, per ora però mi tiene la sedia e mi incita a continuare: “Quello che vi posso dire, e che mi sono preparata a dire, è di sentire questo momento. Di sentire il cielo azzurro, il caldo sotto le ascelle, il fastidio perché c’è troppa gente. La sentite l’ansia di non sapere con che voto ci siamo diplomati? Ecco, provatela tutta. Perché…”, mi schiarisco la voce e mi guardo intorno, mi stanno guardando davvero tutti, e si sbaglia la Sardo a trattarmi così, a dirmi di non farlo, perché sto facendo un discorso motivante, bello, un discorso che ricorderanno tutti quando andranno all’università e cominceranno a dimenticarsi le facce, il tono della voce degli altri, quel giorno in cui non si ricorderanno più il nome della Sardo, e che materia insegnasse, avranno però il ricordo del mio discorso, di me, con i tacchi del diploma che urlo ubriaca nel cortile e comincio a piangere, perché gli argini stanno crollando: “… Dovete provarla tutta questa sensazione, ogni pezzo, ogni istante, perché non tornerà più amici miei, perché nonostante il dolore, la rabbia, l’angoscia, non sarete mai più felici di così”. Ormai singhiozzo e non mi ferma più nessuno, scendo dalla sedia barcollando e mi siedo in mezzo al cortile, esposta sotto gli occhi di tutti.
“Ma che ha?”, dicono, “è pazza?”.
“È solo ubriaca,” risponde uno, “fa sempre così”.
Giulio mi abbraccia, e poi arrivano Sante e Scilla. Ci abbracciamo in silenzio al centro del cortile, davanti ai fratellini minori, e maggiori, ai nonni sopravvissuti. Ci schiacciamo e asfissiamo in un abbraccio lunghissimo, che mi sembra durare più della maturità, più del liceo, mi sembra durare da quando sono nata.
Quando finisce è ora di uscire, non possiamo rimanere lì in eterno. Ci sorridiamo l’un l’altro, stringiamo mani, baciamo professori impettiti, ringraziamo la commissione dell’esame.
Il portone della scuola è tenuto aperto da una zeppa di legno, sciami di ragazzi urlanti escono da scuola, lanciano libri per aria, buttano zaini per terra, si accendono sigarette di fronte a genitori benevolenti, oggi.
Le ultime vacanze da liceali si srotolano davanti al portone della scuola. Giornate lunghe e calde, noiose e dolcissime.
Ci guardiamo in faccia, abbiamo impedito ai nostri parenti di venire a vederci perché volevamo uscire da scuola e andare a pranzo insieme, e poi al parco a prendere il sole, e poi a cena e poi a ballare. Ma ora siamo solo stanchi, con l’adrenalina sempre più bassa e gli occhi pieni di cose che non sappiamo dirci.
Scilla sale sul bus e dice: “Ci vediamo stasera, dai”.
Giulio si accende una canna e monta sulla bici: “A dopo”.
Prendo Sante per mano e andiamo verso casa a piedi: “Mi fanno un male cane le scarpe”, gli dico.
Mi bacia una guancia, spostandomi i capelli ancora nei loro bulbi, e dalla faccia che fa so che sta per dirmi una cazzata.
Ride già, mentre parla: “Allora mi raccomando, sentilo tutto questo male cane, non perderne nemmeno un secondo”.
La foto in evidenza è di Autumntherose. Potete trovarla qui.